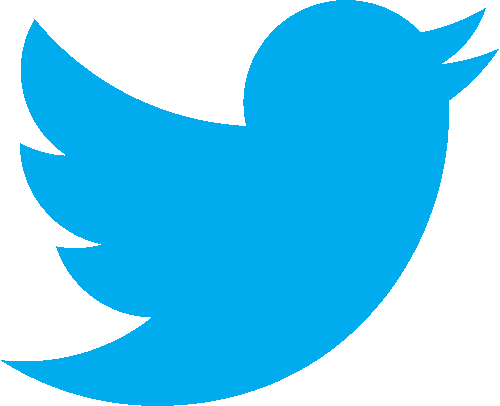Come attivisti del Comitato lavoratori contro la guerra da alcuni mesi ci siano impegnati in una discussione sulle questioni che riguardano l'attuale fase politica in relazione alla crisi economica generale del capitalismo. Abbiamo stilato il documento allegato che proponiamo alla discussione e sul quale vorremmo promuovere un'iniziativa, la più larga possibile, senza alcuna pretesa di affermare verità rivelate e tanto meno indiscutibili. Anzi, a questo punto una discussione aperta a tutto campo ci sembra indispensabile.
Il testo è un po' lungo, ma abbiamo preferito non semplificare sperando di essere riusciti a rendere chiaro ciò che pensiamo. Speriamo che vi facciate forza e lo leggiate!
Inviate i vostri commenti a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
A presto
Guido
Dalla crisi al fascismo? Sta tornando il fascismo? Il rischio del ripresentarsi di una forma moderna di fascismo viene evocato con frequenza in ambienti ridotti ma diversissimi. Vi ha fatto riferimento mesi fa Famiglia Cristiana (che, in verità, insiste, con coerenza, nel denunciare gli aspetti autoritari e razzisti della politica del governo Berlusconi). Ha lanciato un tentativo di discussione Carta (n. 10 del 2008), vi fanno riferimento gli esponenti della ex-sinistra parlamentare e, ogni tanto qualcuno del Pd, persino, sia pur per allusioni, un Di Pietro e un Casini. Per ultimo un certo numero di “indipendenti” di sinistra ha lanciato una lista unitaria non-partitica per le europee denominandola Per la democrazia, con il palese significato che stia per essere abolita. Ovviamente, dal risorgente fascismo.Le occasioni che rendono attuale la domanda non mancano; si vanno, anzi, moltiplicando. La politica anti-immigrati dalle venature sempre più razzistiche, l’accento sull’emergenza securitaria per giustificare una crescente militarizzazione del controllo sociale, l’attacco al diritto di sciopero e alla libertà di manifestazione e di associazione, l’affermazione di un totalitarismo statalista nel disciplinare persino le scelte sul proprio corpo dinanzi al dramma di una vita puramente vegetativa. E, su tutti questi singoli aspetti, l’esplicito disegno di manomettere la Costituzione per dare vita a una forma di stato centralizzata sul potere dell’esecutivo, affrancato dai contrappesi tradizionali del potere legislativo e di quello giudiziario, e, soprattutto, dalla pressione sociale che ha fruito, negli anni della democrazia post-bellica, di un terreno favorevole per condizionare l’attività di governo e parlamenti.Questo magmatico processo avanza attraverso una costante iniziativa “dall’alto”, ma è in grado di suscitare una pressione “dal basso” che sembra renderlo invincibile e inarrestabile. Soprattutto perché sembra godere dell’inusitato vantaggio di non avere di fronte alcuna seria opposizione.Quel che succede in Italia oggi non è, naturalmente, isolabile dalla storia precedente di questo paese, né da quello che succede nell’intero mondo, in particolare con i decenni del “neoliberismo” e della globalizzazione e con l’attuale situazione di marasma causata dalla crisi economica e dal vacillare degli assetti geo-politici mondiali seguìti, in particolare, al fallimento dell’“unilateralismo” bushiano.La risposta alla domanda sul ritorno del fascismo non può essere data, dunque, isolando la “questione Italia” da tutto il resto, ma tenendo saldamente in conto l’intero contesto e, al suo interno, le “specificità italiche”.Tuttavia, con il presente contributo non pretendiamo di dire “tutto su tutto”, ma, da un lato, cerchiamo di rispondere alla domanda specifica sul ritorno del fascismo, dall’altro, di aprire degli sprazzi su qualunque altra questione che vi abbia attinenza. Lo scopo non è quello di contribuire unicamente all’analisi, ma, soprattutto, a cercare di delineare i contorni politico-programmatici di un’iniziativa e di una resistenza che siano in grado di porsi all’altezza della situazione presente, in cui il sistema capitalista mondiale mette a nudo la sua incapacità di dominare la carica esplosiva delle sue interne contraddizioni, ma, non per questo, dichiara bancarotta e toglie il disturbo, ma torna, anzi, con accresciuta ferocia a cercare di rinsaldare i presupposti e le fondamenta del suo dominio.Con l’umiltà di chi è consapevole di non avere ricette da propagandare, ma vuole contribuire a ricercarle, anche solo svolgendo il più elementare dei compiti: cercare di individuare le domande giuste. La discussione sull’argomento è, a sinistra, piuttosto asfittica. Forse perché riprendersi dalla batosta è duro. Forse perché c’è la inconsapevole percezione che non ci si possa riprendere dalla batosta tornando semplicemente a ripetere vecchi schemi. L’interrogativo sulla situazione presente, insomma, non può essere slegato dalla necessità di un bilancio storico della sinistra, che rifiuti di prostrarsi riverente ad alcun tabù.La complicazione si ingigantisce perché chi dichiara di fare un tale bilancio ne deriva immancabilmente l’esigenza di una sinistra che rinneghi ogni carattere antagonista/alternativo e si sottometta allo stato presente delle cose. Chi rifiuta la soggezione e aspira a una sinistra pur sempre alternativa, si limita, per lo più, a bilanci molto parziali, o alla ricerca di errori più o meno recenti. Come se potesse essere sufficiente correggere qualche dettaglio tattico del passato per ricreare una forte sinistra. Un’illusione molto, molto, pia.Il seguente materiale non è stato elaborato per perseguire lo scopo di salvare questo o quel pezzo di sinistra, né per proporre un impianto “chiavi in mano” di una “nuova” sinistra. Riteniamo il primo una missione inutile: non c’è nulla da salvare in quegli ambienti che sono colti da terrore solo dinanzi al fatto di vedersi esclusi da ogni rappresentanza nelle istituzioni. Che dal disastro attuale di un intero ciclo del movimento operaio non derivano neanche la necessità di un bilancio davvero complessivo, ma che seguitano a re-iterare autisticamente i vecchi schemi con inerzia compulsiva.Sappiamo che il secondo è impossibile, almeno nel momento attuale e per le scarse forze nostre e di quanti su questa strada si muovono.Eppure, crediamo che la crisi esplosa nell’estate del 2007 non sia il crollo di una particolare versione del capitalismo, quello “neo-liberista”, talché sarebbe possibile “tornare” al buon vecchio capitalismo d’antan, ripulito dalle frenesie degli ultimi trent’anni, e rispolverandone tutti i corollari (una certa democrazia, un certo compromesso sociale, certi sindacati e certi partiti), ma stia mettendo all’ordine del giorno la necessità per l’intero genere umano di superare il sistema di produzione e scambio costruito in un paio di secoli dal capitalismo. Un sistema che, ormai è visibile, non solo non garantisce più la sopravvivenza immediata dell’umanità (la sua riproduzione) persino nei luoghi in cui mena vanto di essere “più sviluppato”, ma che attenta alla possibilità stessa della vita, con la distruzione della natura e il moltiplicarsi delle guerre.Per realizzare il cambio c’è bisogno di un movimento, di un programma e di organizzazioni in grado di esplicarsi a scala mondiale. Segnali in questa direzione non ne mancano e vi faremo qualche accenno più innanzi, ma l’interrogativo che qui ci interessa è uno soltanto, e rientra, non di meno, tra i tanti che quel movimento deve porsi, quel programma deve risolvere, quelle organizzazioni devono assumersi in carico.La risposta non si può dare in astratto, e deve considerare almeno due cose: cosa è stato il fascismo e come è stato affrontato dall’anti-fascismo. Quale lettura, dunque, ne ha dato la sinistra che lo ha fronteggiato e che oggi, con poca gloria, scompare. Un bilancio serio della vecchia sinistra, per gettare almeno un granellino di sabbia nelle basi nuove su cui crearne una all’altezza dei tempi. Il fascismo storico Il carattere essenziale da sempre sottolineato a sinistra è che il fascismo fu un regime liberticida, anzi democraticida. Abolì la democrazia parlamentare per sostituirla con la dittatura di un unico partito, anzi, in ultima istanza, di una persona sola. I mezzi impiegati allo scopo: culto del capo, militarizzazione, controllo dei media, produzione artificiosa di un immaginario collettivo teso a far sentire il popolo non diviso in classi, ma affasciato nella nazione italica come un sol uomo.Negli anni recenti s’è fatto spazio un altro elemento caratterizzante del fascismo: le leggi razziali. È curioso che per decenni la sinistra abbia tenuto un po’ la sordina su questo carattere, iniziando a sottolinearlo con forza solo dopo che Israele ha avviato la sapiente costruzione dell’industria dell’Olocausto per rinsaldare i motivi della sua esistenza come stato mono-etnico e… spillare un po’ di soldi a mo’ di riparazioni (finiti in gran parte alle organizzazioni che difendono lo Stato d’Israele, e poco o niente ai sopravvissuti). Il fascismo, oltre che dittatoriale, dunque, fu anche razzista, beninteso solo contro gli ebrei, ché degli altri ci si può bellamente continuare a dimenticare, salvo fuggevoli ammissioni ove si tratti di fare affari con la Libia e trasformarla in una barriera contro l’immigrazione…(D’Alema ieri, Berlusconi oggi).Fu davvero il fascismo solo questo, o principalmente questo? A quale scopo Mussolini in Italia, e Hitler in Germania, assunsero su di sé tutto il potere? Perché avevano un’idiosincrasia genetica verso la democrazia, ed erano, magari, affetti da una paranoica bramosia di potere personale e di odio viscerale contro gli ebrei?Della democrazia, in verità, entrambi usarono per assurgere al governo, salvo disfarsene di lì a poco per un ben preciso motivo, su cui oggi fin troppo facilmente si sorvola: la ritenevano incapace di sconfiggere il comunismo, vero mostro che ne agitava i sogni. All’epoca il comunismo non era una pura parola, ma l’aspirazione dichiarata di potenti movimenti sociali e politici, che s’era materializzata nella rivoluzione russa e aveva pericolosamente lambito lo stesso risultato in Europa, particolarmente in Ungheria, in Baviera, in Italia (“biennio rosso”) e nell’insieme della Germania (anche oltre gli anni focosi del primo dopo-guerra).Il fascismo fu, dapprincipio, reazione pura contro la minaccia della rivoluzione comunista. Reazione non delle classi agrarie che s’opponevano allo sviluppo del capitalismo, ma di tutte le classi possidenti che difendevano i loro privilegi contro l’avanzare della rivoluzione sociale che minacciava di espropriarglieli. Una lettura degli scritti di Hitler sarebbe molto interessante per capire come il suo odio anti-ebraico non fosse affatto l’odio del piccolo-borghese che temeva la concorrenza dell’ebreo negli affari, ma l’odio di chi vedeva nell’ebreo il veicolo energico del nuovo verbo comunista. Non era pazzo, gli ebrei erano davvero diventati, a milioni, militanti coraggiosi del socialismo prima e del comunismo poi. Non perché volessero sottomettere il mondo al potere della loro setta, ma perché erano stati precipitati, dal capitalismo, nella condizione di miserrimi artigiani prima e, poi, con lo sviluppo dell’industria, messi fuori dal mercato, fuori, dunque, dalla stessa possibilità di sopravvivere nel nuovo sistema che prendeva piede.La reazione fu, all’inizio, violenza pura: i comunisti andavano distrutti. Ciò fu realizzato con l’aiuto dello stato, prima, durante e dopo la presa del potere. Le organizzazioni comuniste e socialiste furono sistematicamente demolite e ogni agibilità politica gli fu negata. Un lungo discorso sarebbe da fare sulle ragioni del prevalere della reazione (ci furono errori dei comunisti, e quali? O la situazione non era ancora matura per il prevalere di forze sociali antagoniste al capitalismo?), ma la sede per affrontarlo non può essere questa. Quel che è certo è che, liberata la scena dalla presenza dei comunisti organizzati, rimaneva pur sempre il problema di che cosa fare con la massa che s’era decisa a seguirli non perché ubriaca, ma perché mossa da pressanti determinazioni materiali, che la guerra e la situazione economica che ne era seguita avevano reso ancor più esplosive.Sul punto le soluzioni di Hitler e di Mussolini non differirono quanto a sostanza. Entrambi propugnarono un socialismo nazionale. Entrambi, cioè, affettarono di far proprie le rivendicazioni operaie e proletarie, per realizzarle in un ambito rigidamente nazionale e allo scopo dichiarato di ottenere, in questo modo, un accorpamento delle classi sfruttate alle politiche di “riscatto” e di rilancio del proprio paese. La Germania era uscita sconfitta dalla guerra, aveva da pagare le pesanti riparazioni decise a Versailles ed era in preda a sconvolgimenti sociali e politici. L’Italia era ufficialmente nel novero dei vincitori, ma dalla guerra era uscita svenata, e, a sua volta, scossa da sommosse, e col rischio di rivoluzioni. Entrambi i paesi, inoltre, da un punto di vista capitalistico, erano davanti a un acuto dilemma: diventare grandi potenze o rimanere gregari delle grandi potenze che dominavano il mondo. Per diventare potenza andava conquistato un proprio spazio nei territori da colonizzare (lo “spazio vitale” di mussoliniana e hitleriana memoria) e andava ingaggiato un conflitto aperto con le potenze che glielo sbarravano.Risiede in ciò il motivo per cui Italia e Germania ricorsero al fascismo per sconfiggere la minaccia comunista, mentre in altri paesi lo stesso obiettivo poté essere perseguito senza abolire la democrazia formale. Per questi due paesi, infatti, la reazione al comunismo si saldava con l’esigenza di “farsi spazio” in condizioni di grandi difficoltà, il che implicava l’urgenza di un rigido disciplinamento dello stato e una forte mobilitazione nazionalista. Il “cancro comunista” corrodeva l’uno e l’altra.L’aspirazione colonialista aveva, dunque, poco da fare con questioni di prestigio o di potere in astratto, e molto con la possibilità di sfruttare i possedimenti coloniali per sviluppare industrialismo in casa propria, oltre che a liberarsi almeno di una parte dei milioni di contadini che l’industrialismo rendeva eccedenti.Il progetto mussoliniano era lucidamente capitalista e fu lucidamente attuato. L’Italia grazie alla mobilitazione nazionale (ideologica e soprattutto di sforzo di lavoro e di sacrificio bellico) delle classi sfruttate si “riscattò” dalla sua posizione gregaria, conquistò colonie, sviluppò industrie, sottomise l’agricoltura al capitalismo, rafforzò la dimensione finanziaria e militare. La nazionalizzazione delle masse ebbe successo non solo per effetto della sofisticata propaganda (che pure ci fu e fu, per l’epoca, davvero sofisticata), ma soprattutto perché fu in grado di attuare uno scambio reale: lavoro, salario, case, prime – e per l’epoca- avanzatissime forme di welfare state in cambio della difesa della “patria proletaria” contro le “plutocrazie” anglo-sassoni e francese.Il fascismo realizzò, dunque, una sapiente commistione di socialdemocrazia in ambito nazionale, di nazionalismo imperialistico e di statalismo. L’ultimo punto (lo statalismo) fu, forse, il terreno su cui il fascismo dimostrò nel modo più evidente la sua modernità. Lo stato forgiato come la forma massima della comunità nazionale organizzata, che non è solo a servizio dei potenti, ma che si prodiga nella cura del benessere di tutti i suoi componenti, al fine di tenere coesa la comunità nazionale che, in quanto tale, è necessariamente in conflitto con altre comunità nazionali organizzate. La democrazia –ossia il regime politico fondato su più di un partito- venne abolita, ma questo non era il vero scopo del fascismo, ne fu solo un corollario. Per realizzare il suo vero scopo (riscatto del paese nel senso di avanzamento nello sviluppo del capitalismo e arrampicata nelle posizioni dominanti a scala mondiale) il fascismo doveva necessariamente chiudere l’ingloriosa pagina della democrazia liberale, rivelatasi incapace di bloccare le istanze rivoluzionarie, e, nella sua connaturata vocazione a perenni lotte tra camarille, incapace anche di far assurgere l’Italia al ruolo di grande potenza capitalistica global player.Con queste premesse, il fascismo storico non poteva che sfociare in guerra, di conquista coloniale e contro le altre potenze. Le quali, per parte loro, democratiche e persino new dealiste, …facevano conquiste coloniali e preparavano guerre. Se ci eleviamo solo un centimetro dalla vulgata che anima del fascismo fosse il democraticidio, scopriamo, dunque, qualcosa di più della sua essenza: anti-comunismo, nazionalismo, statalismo, imperialismo.Apriamo un piccolo inciso. Quanta parte di questi caratteri (che, peraltro, il fascismo non generò, ma sviluppò in sommo grado) sono traslati come eredità (non abiurata) nella democrazia pluripartitica che l’ha sostituito? L’aggiunta di un semplice aggettivo, democratico (per l’imperialismo, anche “umanitario”), ha reso agevole conservarli tutti.Non peregrino sarebbe anche chiedersi se, e quanto, certi caratteri hanno infettato anche a sinistra. Il discorso porterebbe molto lontano. Notiamo solo, di sfuggita, che non nasce all’improvviso la compassata contesa ingaggiata da Napolitano e La Russa a proposito dell’8 settembre: fu più patriottico chi voleva difendere l’Italia dall’occupazione tedesca, o chi voleva difenderla da quella americana? E, sempre di sfuggita, notiamo come lo statalismo (come eredità dello stalinismo) sia così penetrato dentro la sinistra che, ancora oggi, non riesce neanche a immaginare una qualsiasi politica di trasformazione economico-sociale che non veda come perno centrale l’iniziativa dello stato.
Paralleli con l’oggi
Torniamo al nostro interrogativo, mettendo a confronto il fascismo storico con la situazione attuale.Oggi non siamo in presenza di un rischio evidente di rivoluzione sociale. Alle classi dominanti sembrerebbe, dunque, mancare il primo dei motivi fondanti del fascismo. Eppure queste classi vivono in una situazione di crescente panico. La stabilizzazione (molto) relativamente pacifica seguita al secondo conflitto mondiale è, ormai, minata sotto tutti gli aspetti. Nel mondo emergono nuovi soggetti (non solo statuali, si pensi ai movimenti sociali e politici dell’America Latina, che hanno influenzato la nascita del movimento no global e ne sono stati, a loro volta, influenzati) poco disposti a rimanere confinati nel ruolo di praterie di caccia di risorse e profitti da parte di un sistema che ha cumulato potenza economica, finanziaria e militare in un ristretto pugno di paesi che si auto-definiscono Occidente. Qui, inoltre, non funziona più il paradigma che per oltre mezzo secolo ha garantito la stabilità interna: lo sviluppo della produzione, dei commerci, dei mercati, dei profitti diviene sempre più asfittico e, soprattutto, non si trasforma più in aumento del benessere anche per le classi lavoratrici, e manifesta tutti i suoi aspetti distruttivi dell’ambiente e della vita. Tutto ciò non ha, finora, prodotto alcun fermento di rivoluzione, ma chi ha accumulato ricchezza avverte con galoppante ansia il rischio di perderla. O per il crollo del sistema, o perché la crescente povertà a un polo della società può causare lo scatenamento di reazioni rovinose. O per tutte e due.Se negli anni ’20 la paura del comunismo spinse la borghesia a mettersi nella mani di un sol uomo, un sol partito e uno stato forte, oggi l’oggetto è più misterioso, ma la paura che provoca non è minore.“La paura e la speranza” è il titolo del fortunato pamphlet di Tremonti. Una sua attenta lettura aiuta molto per rispondere al quesito che ci occupa. Ciò che Tremonti vi propugna non è –come inopinatamente qualcuno a sinistra inclina a credere- un ritorno all’intervento dello stato in economia, ma un progetto molto più complesso e articolato che va messo a confronto con le politiche che la destra mette in atto.Anzitutto, Tremonti alla paura dà nome e cognome: la Cina. Secondo lui il frutto più maligno della globalizzazione è stato di aver portato la Cina a consumare come noi e insieme a noi, attingendo alla riserva di risorse che una volta erano solo “nostre”. Una volta liberato, il dragone cinese non si fermerà più e arriverà, secondo Tremonti, a cercare di sottomettere il mondo al suo dominio imperialistico. Come fermarlo? Tremonti non parla apertamente di guerra, ma invita a mettere nel conto di dover affrontare “confronti e conflitti con altri sistemi… non illudiamoci di evitarli chiudendoci nel buonismo imperante”, pag. 80).Prospettiva realistica o pura propaganda? Che la Cina possa soppiantare gli Usa nel padronaggio economico, finanziario e militare del mondo è propaganda delirante, considerato l’incolmabile divario in tutti i campi. Che la guerra con la Cina sia nell’ordine delle possibilità è prospettiva realistica. Di sicuro negli Stati Uniti la preparazione è iniziata da un pezzo (circondando la Cina con un cordone di alleati, paesi occupati e basi militari). La paura dichiarata è che la Cina voglia sottomettere il mondo, la paura reale è che la Cina alzi la testa e si rifiuti di proseguire nel ruolo di fabbrica di prodotti a basso costo che fanno lucrare alle multinazionali Usa grandi profitti e inondano il mercato dell’Occidente di prodotti a basso prezzo favorendovi le politiche di svalorizzazione del salario. Detto tra parentesi: le dirigenze cinesi non hanno alcuna volontà di sottrarsi a questo ruolo (e continuano con i surplus commerciali a finanziare il debito Usa, comprensivo delle spese militari per la stabilità del pianeta), ma la incredibile capacità di resistenza e di lotta delle masse lavoratrici cinesi possono davvero sconvolgere il quadro di sudditanza economico-politica del loro stato nei confronti degli Usa. Non a caso qualcuno negli Usa ha significativamente collegato l’inizio della crisi con il piano deciso dalla Cina di aumentare i salari, disporre l’obbligo di sindacati nelle imprese straniere, incrementare gli investimenti in sanità, scuola e agricoltura. È esagerato far risalire l’esplosione della crisi unicamente a ciò, ma il suo peso l’ha senz’altro avuto nell’aumentare il panico nei mercati finanziari mondiali che vi hanno visto il rischio di riduzione dell’afflusso delle risorse cinesi e, peggio ancora, che potesse ripartire una generale spinta mondiale all’aumento salariale con il conseguente taglio dei profitti delle multinazionali e la riduzione dell’afflusso di risorse verso i mercati finanziari. Fuor di dubbio è il fatto che il piano non fosse un gentile regalo del governo, ma un tentativo di sedare le lotte e le rivolte operaie e contadine che in Cina si contano nell’ordine di decine di migliaia all’anno.Tuttavia, per questo aspetto (nemico esterno) se il fascismo storico individuava nelle plutocrazie il fronte avverso, Tremonti vi sostituisce il dragone fumante.Come è evidente, non basta indicare un nemico per ottenere una mobilitazione contro di lui. Bisogna far crescere un sentimento popolare. Le iniziative non mancano: l’invocazione di dazi protettivi da parte della Lega, le campagne sulle “mafie cinesi”, le provocazioni anti-cinesi (come a Milano), le campagne di denuncia dell’oppressione cinese in Tibet, persino le campagne sul bestiale sfruttamento del lavoro, quasi fosse una caratteristica esclusiva dei cinesi in patria e fuori. Ma Tremonti fa di più: la Cina non è solo un concorrente economico scorretto, ma è la madre di tutto ciò che provoca il rischio di impoverimento dell’Occidente. Per sostenere la sua tesi non esita a saccheggiare a piene mani persino argomenti no-global per addossare ai cinesi le principali responsabilità di inquinamento e distruzione della natura.Sul piano concreto il governo Berlusconi non ha già dichiarato ufficialmente la Cina un nemico da combattere, anche perché non è facile suscitare mobilitazioni simil-belliche in una situazione che vede ancora prevalere sentimenti pacifisti. Inoltre, le attuali difficoltà nord-americane potrebbero anche portare a un cambiamento delle politiche verso la Cina. Delle risorse finanziarie e della manodopera a basso costo di questo paese c’è grande bisogno per cercare di evitare una precipitazione dell’attuale crisi, ed è ben difficile che la Cina accetti di finanziare senza contro-partite il ripianamento degli immensi debiti tossici accumulati in Usa e Europa. Un compromesso Usa-Cina è quasi inevitabile, al momento attuale. Se esso fosse il preludio di un’alleanza di lungo corso avverrebbe, probabilmente, a danno anche dell’Europa. Il che darebbe nuovo fiato alle teorie anti-cinesi di Tremonti.Al di là, comunque, del rilievo specifico della Cina, le campagne contro rom, romeni, immigrati, stanno, pian piano, ottenendo il risultato di diffondere a livello di massa la convinzione che le minacce di impoverimento non derivano da un sistema economico-finanziario vampiresco, ma dallo straniero che viene a mangiare sulla nostra tavola senza partecipare alla produzione della nostra ricchezza, e, soprattutto, che è necessario passare alle vie di fatto, da parte dello stato e da parte dei cittadini. Tremonti sembra assistere distaccato alle politiche del suo capo e dei suoi colleghi ministri (nel suo libro condanna, persino, la “malapianta del razzismo”), eppure il processo che avanza si inquadra perfettamente in quello da lui descritto, e suggerisce al suo libro anche un più appropriato titolo: dalla paura alla rabbia.Si compie, in questo modo, un passo decisivo cui risulterà più agevole far seguire il successivo che dia, a livello di massa, nome e cognome a un solo paese o a un gruppo di paesi, nel caso la Cina riuscisse a stringere alleanze (una candidata al ruolo è la Russia, contro la quale, non a caso, si continuano a usare parole di fuoco per descriverne l’immarcescibile vena imperialista, anche con disinformazioni plateali, come nel caso della guerra osseta. Se ne distanzia, comunque, Berlusconi, non tanto per l’amicizia con Putin, quanto perché coltiva la speranza di sviluppare proficuamente gli affari italo-russi, allargando i mercati al commercio italiano e attirando capitali russi in Italia).Non si può certo negare che tali campagne abbiano avuto finora un crescente consenso, anche in strati popolari. Anche nel proletariato di fabbrica il virus del razzismo sembra non trovare ostacoli. Spogliati dalla possibilità di agire come comunità di lotta capace di influire sulle imprese e sullo stato, i proletari si ritrovano soli a difendersi dall’impoverimento e dall’insicurezza e finiscono con il concentrarsi sulle proprie (misere) proprietà che gli appaiono minacciate dagli ultimi arrivati. In assenza di vincoli di classe il lavoratore rimane puro individuo, e nella società capitalista l’individuo esiste (e sopravvive) solo per la sua proprietà materiale.
La paura e la speranza
Il nemico esterno è, dunque, individuato. Si tratta, ora, di individuare il “noi”. Tremonti, pur senza rinnegare accenti nazionalistici, lo trova nell’Europa. Quale? Non quella del “mercatismo”, dell’illusione del “denaro che crea denaro”, delle burocrazie e delle regole infinite, ma quella in grado di ritrovare la sua cultura, le sue tradizioni, la sua storia, in una parola la sua civiltà, ritornando alle sue radici giudaico-cristiane. Un’Europa rigenerata che si fondi essenzialmente sullo sforzo di lavoro e sul sacrificio del suo vero cuore produttivo, la massa dei lavoratori. L’Europa proletaria contro la minaccia cinese, creata dalla globalizzazione.La creazione del “noi” è, dunque, non solo una prospettiva lontana e astratta, ma delinea un programma politico di fase: la lotta contro questa Europa corrotta e imbelle. Un programma che civetta, in modo dichiarato, con molte delle pulsioni popolari anti-europee e che contesta, almeno a parole, uno dei capisaldi dell’Europa attuale: l’economicismo e il liberismo anti-statalista.Per assumere su di sé il compito del rilancio europeo lo stato deve tornare a occuparsi pienamente di economia, ma deve anche, e soprattutto, divenire artefice di una nuova politica basata su di un insieme articolato di valori. Sette sono, per Tremonti, le parole d’ordine per salvarsi dalla crisi globale: valori, famiglia, identità, autorità, ordine, responsabilità, federalismo.Tranne che per il federalismo la similitudine con parole d’ordine fasciste è di tutta evidenza. E, in analogia con il fascismo, si cerca di delineare un orizzonte che prefiguri una generale rigenerazione della società e dello stato (ciò che il fascismo chiamava la sua “rivoluzione”). Non solo si chiede al popolo di uniformarsi a quei valori, ma gli si chiede di mobilitarsi per ottenere che lo stato e i suoi reggitori politici vi si adeguino.Il progetto tremontiano non presuppone affatto l’abolizione della democrazia formale, aspira, se così si può dire, a una democrazia molto partecipata, a una mobilitazione permanente del popolo, purché fondata su una condivisione di valori che forgino una comunità popolo-stato fermamente orientata a rinsaldare i propri vincoli nella contesa economica mondiale e a “confrontarsi” con il nemico cinese e, più in generale, con i popoli che dalle periferie del mondo stanno alzando troppo la testa contro le politiche di rapina che li hanno sistematicamente spogliati delle risorse naturali e di lavoro. È un progetto organico che, come negli anni ’20, pesca nel bagaglio di sinistra (anche di quella “estrema” e no-global) e si dialettizza con aspirazioni delle classi lavoratrici per piegarle a un orizzonte nazionalistico-europeo. Considerate le macerie che la sinistra sta lasciando dietro di sé nella sua infinita agonia, l’operazione si presenta, tutto sommato, facile. Tuttavia, l’operazione non è senza contraddizioni. Consideriamo l’ultimo dei punti. Lo stato.Il fascismo fece dello stato un feticcio. Sommo potere sulla società e massimo organo politico della nazione. Mentre affermava il monopolio della forza sterminando ogni opposizione, lo stato assumeva anche la direzione sul terreno dell’economia e delle politiche sociali. Grande impulso alla costruzione di industrie e infrastrutture, all’incremento della produttività in agricoltura, alla formazione di un sistema del credito orientato rigidamente alla crescita interna, ma anche grande impulso alla “cura” dei cittadini. Le due cose stavano insieme. Tanto più l’autorità dello stato era riconosciuta, quanto più esso si prodigava anche per i lavoratori e per il popolo e non solo per i magnati dell’industria e della finanza, verso i quali, anzi, c’era una polemica nemmeno troppo velata per le tendenze molto individualiste e poco nazionaliste.Il fascismo poté erogare welfare statale e imporre alle aziende un certo rispetto del lavoro senza che ciò avesse conseguenze negative sulla crescita economica, anzi come condizione per favorirla, nel quadro di uno sviluppo “auto-centrato” fondato sull’“autarchia”, il saccheggio coloniale e la crescente produzione bellica, prima per le campagne africane (dove la resistenza non smise mai di impegnare duramente le truppe italiane che ebbero modo di distinguersi per ferocia e disumanità nella loro opera di diffusione della “civiltà”), poi per prepararsi al conflitto mondiale che cominciò ad incubare apertamente negli anni trenta. Questa politica fu, peraltro, agevolata dal fatto che tutto il mondo “sviluppato” perseguiva politiche analoghe per uscire dalla crisi del ’29 e ridisegnare nuove linee di coesione sociale dopo la paura del comunismo suscitata negli anni ’20 dalle rivolte proletarie.Tremonti è consapevole che l’attuale situazione del capitalismo mondiale non consente di riproporre la coniugazione tra crescita e diffusione del benessere anche alle classi lavoratrici. Del pari è consapevole che un protezionismo nazionalistico simile a quello degli anni trenta è impossibile. Al massimo è immaginabile un protezionismo europeo, ma anche questo avrebbe ben poco da offrire sul piano materiale alle classi lavoratrici, senza considerare che, anche all’interno del quadro europeo, l’Italia ha margini di manovra molto più risicati degli altri paesi.Il capitalismo odierno si regge unicamente sul pompaggio di profitti da ogni settore produttivo, dalla stessa vita umana e dell’ambiente naturale, verso il conglomerato internazionale di potenti organizzazioni finanziarie. Queste, a loro volta, non sono costituite da un ceto particolare che specula parassitariamente sulla produzione materiale di ricchezza. Il nazismo e il fascismo potevano dipingerla così, descrivendo la finanza come la sede in cui si concentrava il potere ebraico parassitario sopra-nazionale; ma questa -che già all’epoca era una caricatura data in pasto al popolo per alimentarne lo sforzo produttivo e l’odio anti-ebraico- non è oggi più proponibile. La finanza è divenuta definitivamente il capitale stesso, il luogo in cui qualsiasi possessore di capitali deposita le sue aspettative di profitto, sapendo di avere molte più possibilità di guadagno partecipando alla suddivisione dei profitti generati dalla produzione mondiale che investendo nella sua piccola o grande unità produttiva. Solo la finanza, infatti, permette anche al più piccolo investitore di partecipare allo sfruttamento di interi paesi (con i prestiti internazionali) e persino alle più misere forme di sopravvivenza nelle lande più decentrate in relazione al mercato mondiale (con il sostegno, magari, di mistificanti “aiuti allo sviluppo”). L’unica condizione per rendere appetibile l’investimento produttivo è quella di deprimere ulteriormente i salari. La depressione dei salari costringe i salariati a cercare di integrare i propri redditi ricorrendo, a loro volta, al mercato finanziario anche solo per garantirsi la propria riproduzione (mutui per la casa, la scuola, la sanità, pensioni). Ciò, da una parte, chiude il ciclo infernale del profitto che non si realizza solo nello sfruttamento del lavoro di fabbrica, ma che si realizza anche costringendo il lavoratore a ripagare gli interessi su quanto gli viene prestato per sopravvivere, ma, dall’altra parte, lega indissolubilmente anche i lavoratori alla “stabilità” del sistema finanziario. Se i confini tra capitale “produttivo” e capitale finanziario sono sempre più sfumati, diventa sempre più difficile mettere il primo contro il secondo, e chiamare allo “sforzo produttivo” promettendo ricadute salariali dirette o indirette.Non sarà l’attuale crisi finanziaria a ristabilire un ipotetico nuovo equilibrio tra produzione e finanza. La finanza continuerà, magari con qualche “regola” in più e maggiore intervento statale, a dominare e a sottomettere ogni aspetto della vita individuale e sociale alla necessità generale dell’accumulazione. Tremonti lo sa e lo condivide con convinzione (al di là di spunti polemici propagandistici). Infatti, non prospetta neanche lontanamente un ritorno dello stato a politiche sociali. Anzi programmaticamente le esclude e delinea un quadro di progressivo ritiro dello stato da ogni incombenza sociale. Qui è, forse, il punto più interessante dell’impostazione tremontiana. Il fascismo conquistò il consenso alla mobilitazione sciovinista ricorrendo alle funzioni sociali dello stato. Tremonti vorrebbe suscitare la stessa mobilitazione, ma non può maneggiare gli stessi strumenti. Per meglio dire, progetta un uso decisivo dello stato nel disciplinare le forze in funzione della contesa internazionale e della conservazione della stabilità interna, ma non può programmare un uso dello stato che imponga alla classi possidenti un contenimento delle pretese di profitto al fine di finanziare la coesione sociale necessaria a sostenere lo sforzo competitivo e conflittuale. Le prove si sono già viste con la demagogia sulla “Robin tax” e sull’Alitalia (un regalo a una banda di “prenditori” dato in cambio di altri regali su grandi opere, concessioni ed Expo). D’altronde, la classe che rivendicava la sua superiorità nella capacità di rischiare, è oggi, in tutto il mondo, ripiegata nella ricerca del massimo profitto con il minimo rischio ed è diventata esperta solo nelle forme di investimento che scaricano su altri il rischio e, in ultima istanza, sullo stato (che, non a caso, si stanno spolpando per evitare l’esplosione della bolla finanziaria).Ma se lo stato si ritira dal sociale, come fare per evitare una generale sollevazione di masse svenate dall’intensità del lavoro, dai bassi salari, dalla precarietà e dall’assenza di servizi pubblici gratuiti o a basso costo in settori quali la sanità, la scuola, la previdenza? La parolina magica è sussidiarietà. Il significato non è solo quello di allargare il settore di intervento di potenti organizzazioni assistenzial-finanziarie come la Compagnie delle Opere (o, al limite, delle stesse “coop rosse”), ma quello, molto più ambizioso, di suscitare nella stessa società le energie per far fronte ai bisogni diffusi e inappagati.Riscatto dei valori identitari, iniezioni di etica nella vita politica e in quella civile, possono, infatti, servire a ricreare un senso della comunità, che non si limiti a estrinsecarsi sul piano politico nazionalistico, ma possa dar vita a una pratica sociale, aiutata dallo stato, in cui si riscopra anche il piacere di lavorare non in cambio di denaro, ma come manifestazione della propria carica vitale elargita, naturalmente, nei confronti dei propri “simili”, dei componenti della comunità d’appartenenza. Un comunitarismo nazionalistico (con proiezione europea) che rinsaldi i vincoli sociali, allegerisca lo stato da aspettative eccessive e ristabilisca un rapporto società-stato in cui la società non si limiti a rivendicare allo stato, ma si auto-organizzi in alcune funzioni, disciplinandosi, per il resto, al comando statale sul piano interno e su quello esterno di confronto/conflitto con altre comunità statali organizzate o con comunità viventi in stati “falliti” o mai nati.Uno stato non meno totalitario di quello fascista nel reprimere dissenso e opposizione (il terreno alla sua blindatura è stato, peraltro, concimato anche dal centro-sinistra, governante ai tempi di Napoli 2001, preparatore di Genova 2001, emanatore della legge sui “siti strategici” da proteggere manu militari dai movimenti di protesta, e portatore di tutte le campagne sulla “sicurezza” e di ciò che ne consegue, militarizzazione e razzismo), che non rinuncia alla democrazia, ma si ritira dall’ambito sociale, riconoscendo alla società una (pur sempre limitata) autonomia che pretende, tuttavia, di dirigere nel suo esercizio.La prospettiva è meno evanescente di quel che a tutta prima può apparire. Il problema dell’auto-organizzazione della società, in modo autonomo dallo stato, comincia a porsi sul terreno pratico, dell’esperienza concreta di vita, in modo sempre più palese. Chi non lo vede, o lo vede poco, è la sinistra in tutte le sue componenti, che continua ancora a vivere nel mito dello stato come agente esclusivo delle trasformazioni sociali, sia quando vuole prenderne la direzione per via elettorale, sia quando la vuole prendere per via rivoluzionaria. Si può argomentare che Tremonti progetti un ritorno al fascismo? Se ci si limita a considerare del fascismo il solo aspetto abolizionista della democrazia formale, bisogna dire che non ve n’è traccia nelle sue formulazioni, né dalle sue ipotesi deriva, soggettivamente e oggettivamente, la prospettiva abolizionista. Non vi è cosa, in quelle da lui prospettate, che non si possa realizzare persino conservando il quadro normativo costituzionale attuale, tuttalpiù con qualche modifica della “costituzione materiale”, che per essere realizzata non ha neanche bisogno di variazioni nel quadro normativo. Il suo progetto è diverso dal fascismo storico e, in una certa misura, aspira a qualcosa “in più” di quanto esso realizzò. Del fascismo riprende e aggiorna molte fondamentali lezioni, che, spesso, a sinistra non sono state nemmeno comprese a causa dell’abbagliamento provocato dalla sterile contrapposizione fascismo/democrazia. Dalla paura alla rabbia Prima di interrogarci sui modi di contrastare questo progetto è necessario chiederci se e come esso si stia realizzando.Va fatta qui una premessa. Se siamo partiti dal libro di Tremonti non è perché lo riteniamo la bibbia della destra italiana. Il successo editoriale ha contribuito senz’altro a diffonderne le idee, ma ciò non autorizza a intendere il suo come il progetto assunto nel loro insieme dalle forze politiche del centro-destra.Anzitutto Tremonti non elabora niente ex-novo, ma si limita a dare coerenza logica a un insieme di impulsi e argomenti che si sono fatti spazio in modo magmatico in una destra costruitasi attorno a tre opzioni fondamentali (schematicamente: nazional-liberista, nazional-statalista, e federalista, quest’ultima originariamente ancorata a una istanza socialdemocratica “moderna”, e persino anti-Usa, divenuta poi un miscuglio di liberismo-statalismo in salsa localista, oltre che fervente soldatino della bushiana “guerra al terrorismo islamico”). Secondariamente la sua sintesi, pur trovando estimatori trasversali tra le varie tendenze della destra, non ne ha affatto eliminato le divisioni di fondo, per quanto queste abbiano nel tempo conosciuto delle evoluzioni. Ne consegue che sarebbe molto difficile trovare nell’azione politica e di governo un’evidente coerenza con le tematiche e le indicazioni dell’autore. Lui stesso, peraltro, nell’azione di governo “fa quel che può” e non sempre è coerente con le cose che ha scritto (anche se questo rivela, più che altro, la valenza semplicemente propagandistica di talune asserzioni: si confrontino per esempio le tirate contro il “mercatismo” con le generose prebende alle banche, offerte con l’esilarante affermazione di dargli i soldi affinché li prestino a imprese e famiglie, come se non fosse possibile per il governo darglieli direttamente, se davvero volesse. Per non parlare poi della generosa e atavica acquiescenza verso gli evasori fiscali). Tuttavia l’iniziativa politica della destra e del governo stanno producendo dei fatti che non sono senza significato. I più visibili li abbiamo già citati (razzismo, riduzione degli spazi di agibilità sindacale e politica, militarizzazione del controllo sociale), ma quello, forse, più importante è il grande, ed efficace, lavoro per creare un “consenso dal basso” verso l’autoritarismo dall’alto. C’è, in questo, un abile costruzione del “clamore” per giustificare la decretazione d’urgenza e stabilire un nesso diretto tra “volontà popolare” e azione dell’esecutivo, ma c’è anche una sottile capacità di interpretare i voleri di una base sociale che, causa il terrore dell’avanzare della crisi e dell’incertezza, è sempre più disposta a ricorrere ai mezzi duri contro tutte le minacce e a conferire, per questo, allo stato ogni potere per fronteggiarle.L’ossessione securitaria, per esempio, non nasce solo dalle campagne dei media, ma sorge da una fonte spontanea, la paura di quelli che il filosofo polacco Zygmunt Bauman chiama “scarti umani”, che sono oggetto della discriminazione-odio-violenza soprattutto da parte di altri scarti umani o di soggetti sul punto di diventarlo, che vedono nei primi la propria immagine riflessa in uno specchio deformante e orrifico. Questi soggetti sono spessissimo essenziali per la produzione materiale e per tanti lavori nei servizi, ma xenofobia e razzismo sortiscono il salutare effetto di emarginarli e tenerli sotto ricatto, in modo da costringerli a salari bassissimi, utili anche per scatenare la concorrenza con la manodopera indigena. Per coltivare l’ossessione non c’è bisogno, dunque, di creare capri espiatori cercando soggetti che non esistono, ma si utilizzano quelli che esistono per indirizzargli contro paure che scaturiscono da altre cause.Anche la xenofobia e il razzismo non sono semplicemente promossi dall’alto, ma esistono e si sviluppano in modo autonomo. Forse non sono diventate ancora maggioritarie, ma certo sono ormai molto più visibili delle attitudini solidaristico-cooperative e danno continue prove di crescita, dai pogrom anti-rom, ai linciaggi degli stranieri, all’uccisione da parte di italiani dell’operaio italiano Tommasoli, anch’egli di razza diversa, perché girava col “codino” in una zona “proibita” di Verona. Azioni che avvengono, spesso, indipendentemente dal supporto di gruppi neo-fascisti o leghisti, e, infatti, spesso gli autori delle violenze razziste “non fanno politica”, il che significa che sono ben più “politici” dei politicanti.La carta bianca offerta allo stato per il ricorso a mezzi spicci e violenti trova, per altro verso, alimento nella rabbia sorda, individualista, microconflittuale (l’automobile accanto alla mia non contiene uno sfigato in coda come me per andare/tornare dal lavoro, ma un mio nemico mortale), anch’essa figlia del terrore che si diffonde con l’avanzare della crisi e dell’incertezza.Lo stesso federalismo (che è concetto opposto a quello contrabbandato da destra e sinistra in questi anni, essendo “foedus” un patto di unione tra ciò che nasce separato, e non viceversa) è frutto di una tendenza a considerare reale la possibilità di una secessione dei più ricchi dai più poveri, ossia dei territori più ricchi dai più poveri (il ricordo è fresco, tragico, e assai vicino nel tempo, con la dissoluzione della Yugoslavia. Anche lì c’era di mezzo il Vaticano e soprattutto la Germania). In questo senso la risposta popolare, ampia e diffusa, e radicalmente negativa, al referendum del 2006 sul progetto di stato al tempo stesso bonapartista e federalista è stata immediatamente archiviata, soprattutto dai promotori del referendum stesso.Questo fertile intreccio tra “pulsioni dal basso” e “comando dall’alto” per garantire un governo che interpreti fedelmente il “volere popolare” si avvale dell’apprendimento dal fascismo storico di un’altra fondamentale lezione: quella di non tendere a eliminare completamente il dissenso e gli scontri bensì a internalizzarli. I dissenzienti che agivano in un quadro antagonista o alternativo al fascismo erano eliminati senza scrupoli, ma le radici sociali e politiche del loro dissenso erano trattate in modo diverso. Per quanto autocratico e centralizzato fosse il potere mussoliniano, infatti, il duce si circondava di personale, a livello centrale e locale, che aveva impostazioni diverse dalle sue, talvolta radicalmente diverse. Gli scontri non mancarono di certo, fino a culminare col 25 luglio ’43 (anche se poi le cose sono andate diversamente da quanto si potesse prevedere in quel frangente). Il fascismo fino a quel ’43 restava sempre in piedi, nonostante e anzi, per molti aspetti, proprio grazie a questa capacità di internalizzare i dissensi e gli scontri, alla capacità, cioè, di essere una cosa e, al tempo stesso, il suo contrario. Uno, nessuno, centomila, così è se vi pare. La realtà non è una sola (non a caso, forse, Pirandello, aderì al fascismo). E così è dal fascismo che nascono il codice Rocco (penale sostanziale –tuttora in vigore pressoché integro- e di procedura penale, strumenti di repressione delle classi pericolose), ma è dal fascismo che nasce la legge urbanistica che introduce, a suo modo, l’idea di programmazione del territorio in mano non alle imprese ma alla “collettività” (e pur essa in parte in vigore, e comunque su di essa si sono poi modellate le successive riforme, a cominciare dalla “Bucalossi” del 1977). Questa prerogativa sembra essere tranquillamente acquisita dalla destra attualmente al potere, con Fini che fa il contrappunto a Maroni sul tema immigrati e a Berlusconi sul “caso Englaro” e Bossi che raggela le ansie autoritarie del cavaliere ergendosi a protettore di Napolitano e della costituzione o offrendo sponda a Franceschini per misure “solidaristiche” di prelievo sui ricchi a favore dei più poveri.A compimento di questa tendenza a internalizzare il dissenso, la destra costituisce il partito unico denominandolo “il partito degli italiani”. Ciò da un lato sta a significare che gli altri non sono veramente italiani, e dall’altro che si vogliono appunto raccogliere tutte le tendenze presenti nella “nazione”, in modo da smussarne ogni potenzialità antagonista o alternativa.
Il ruolo del neo-fascismo
Il fascismo storico nacque dalla necessità di una battaglia contro il comunismo. Una battaglia vinta anche grazie all’aiuto di una combinazione di movimenti variegati da cui seppe trarre linfa vitale (lo steso Mussolini era stato socialista e direttore dell’“Avanti”) e da diverse impulsi (il sindacalismo rivoluzionario, il futurismo, il razionalismo in architettura, ecc.). Fu movimento e fenomeno storico “vincente”, teso verso un futuro “radioso”. Il neo-fascismo, invece, nacque da un disastro immane, dalla voragine gigantesca, e mai colmata, della sconfitta incondizionata (e al prezzo di milioni di morti). Anch’esso, come il fascismo storico, coltiva il mito del duce, ma la fiammella, simbolo del MSI, è quella che arde sulla tomba di un uomo sorpreso in fuga (clandestino, anche se in direzione opposta!) dal proprio paese, non con la moglie, ma con l’amante, e indossando sul corpo l’uniforme di uno stato straniero (alla faccia del “Dio, Patria e famiglia”!).La componente nichilista, di morte e sconfitta, resta come un sistema fognario presente fino agli anni ’80, quando Craxi, prima, e Berlusconi, poi, sdoganano definitivamente i neo-fascisti. Non che fino ad allora non fossero stati utili per contrastare i movimenti sociali con le continue provocazioni e lo stragismo. Ma, da allora, sono stati chiamati a dare un supporto diretto ai nuovi equilibri politici necessari a sconfiggere il sommovimento sociale e politico che aveva contenuto gli “spiriti animali” del capitalismo fino alla seconda metà degli anni ’70.Da allora una parte consistente del neo-fascismo si è insediata nei piani alti della governance globalizzatrice, annacquando gli istinti social-nazionali, mentre un’altra parte continua a coltivare i miti del passato con successo modesto, ma crescente. Il tono nazionalistico dell’iniziativa di questi ultimi viene mantenuto, ma si scontra pesantemente con le spinte localiste che crescono ovunque. Il livello più significativo di successo è, invece, raggiunto su altri terreni, ugualmente congeniali agli eredi dichiarati del fascismo storico, anche se con una inedita alleanza-concorrenza con i nemici dichiarati dell’unità nazionale.Anche questo non avviene per caso o solo per spirito di iniziativa di queste componenti, ma per il determinarsi di situazioni di fatto che si prestano alla diffusione di comportamenti sociali in sintonia con la loro impostazione.Si pensi, per esempio, al territorio. Le esternalizzazioni produttive, l’“out-sourcing”, il “just in time” lo hanno trasformato in un nastro trasportatore psico-patogeno (congestione, ritmi lavorativi insostenibili –e però sostenuti!-, aggressività, inquinamento, morti per strada che sono morti sul lavoro, ecc.) di una gigantesca fabbrica che non è nel territorio, ma è il territorio. Si tratta, tuttavia, di nastri trasportatori di prodotti e beni strumentali diversi da quelli che interessano ciascun individuo, sia quando riguardano un’attività diversa dalla sua, sia quando egli/ella è fuori da ognuna di queste attività. Così il territorio, al di là della sua mitizzazione, non è più amico e madre, ma è ostile e dannoso, estraneo e straniante. Questo senso di “spaesamento” dà impulso ulteriore al diffondersi delle mitologie leghiste ma fornisce negli aspetti di difesa del territorio dallo “straniero” fecondo terreno di iniziativa anche ai gruppi neo-fascisti.Si instaura, insomma, un significativo intreccio tra il nichilismo auto ed etero-distruttivo degli sconfitti del 1945 e la rabbia sociale sorda e individualista dei pauperizzati degli anni 2000, e cioè gli impoveriti, gli sconfitti economico-sociali che subiscono la “deminutio capitis” del passaggio dal ceto medio-agiato degli anni del welfare alla sostanziale proletarizzazione di questi anni (accentuata dalla crisi esplosa nel 2007).Questa consonanza consente alla destra estrema neo-fascista di ravvivarsi e confondersi con il “popolo”, il che gli dà anche la possibilità di riprendere con maggior foga la missione di sempre: aggredire la “feccia comunista” e le sue sedi, e di trovare in questo il suo ruolo nel rilancio complessivo della destra, mantenendo la sua identità politica diversa dalle forze governative, e tuttavia collaborando con loro nell’attacco agli “estremisti” e cercando di suscitare movimenti popolari per tentare di costituire equilibri politici più “coerentemente” fascisti rispetto a quelli propugnati dalla destra governativa.
Fascismo sociale?
Si può chiamare tutto ciò “fascismo sociale”? Intendendo per ciò una identificazione tra “popolo” e potere, tra comportamenti della massa e rappresentanti politici che, tendenzialmente, predispone il terreno per quella forma “avanzata” di democrazia che il fascismo storico preconizzava e lo stesso Tremonti cerca di riprendere? Alcuni episodi offrono dei significativi elementi per comprendere lo stadio cui si è arrivati.La morte di Yorg Haider è evento di grande valore emblematico, in cui un simbolo di questo fascismo sociale (razzismo, Dio, Patria e Famiglia) muore tornando, alla guida di un auto di servizio (pagata, quindi, dalla collettività, o, per dirla con la destra –che, peraltro, di solito è evasore fiscale- “dal contribuente”) a 170 km all’ora su una strada dove il limite di velocità era 60, ubriaco fradicio, da festini probabilmente omosessuali. Bene, a destra e nell’elettorato di riferimento, nessuno si scandalizza, come, d’altra parte tutti digeriscono tranquillamente il fatto che la Gelmini, fustigatrice delle scuole del Sud Italia, abbia trasferito la residenza a Catanzaro per sfruttarne la facilità con cui in quel sito si supera l’esame per avvocato.Questi episodi mettono in luce la solita contraddizione di accettare dai propri rappresentanti qualunque “eccezione” purché realizzino i comuni obiettivi? Sono soltanto la manifestazione della “doppia morale”, tipica di ogni regime autoritario in cui il capo, o i capi, possono schermarsi dietro al motto “fate ciò che dico, non quel che faccio”? Probabilmente c’è qualcosa di più e di diverso. Essi svelano una completa identificazione nella logica dell’ognuno pensi a sé stesso, in ossequio alla quale il capo non fa “eccezioni”, ma solo quello che ognuno dei suoi estimatori, se potesse, farebbe a sua volta.Dallo stato si pretende, insomma, che sia determinato nel tenere a bada gli “scarti umani” e chiunque attenti all’ordine costituito, ma il fondamento di tale ordine è la piena libertà di chi ha mezzi e risorse di fare quel che più gli aggrada per arricchirsi. La Thatcher dichiarava di non conoscere alcuna “società”, ma solo “individui”, Berlusconi rappresenta al meglio la figura di statista del genere. Il suo massiccio consenso si fonda in buona misura proprio sull’apprezzamento delle capacità dimostrate nell’arricchirsi sfruttando in sommo grado tutti gli interstizi legali, sfiorando o sforando spesso l’illegalità, non avendo remore nell’utilizzare appoggi politici, fino a piegare lo stato stesso alle necessità delle sue aziende e di quelle dei suoi amici. Chi tra i suoi sostenitori non vorrebbe ripercorrerne la via? Il messaggio suona suadente anche all’interno di strati sociali che tradizionalmente s’erano consolidati sulla trincea di difesa collettiva, solidaristica, e che oggi, dinanzi al fallimento di quell’esperienza, non trovano nulla di più attraente che immaginarsi dei piccoli Silvio, o di riconoscersi in lui come materializzazione del proprio individuale sogno.L’equazione popolo/stato che la nuova destra propone è, dunque, dissimile da quella del fascismo storico. Mentre il secondo utilizzava a piene mani la solidarietà sociale per unificare il popolo in un sol uomo/nazione, la seconda per ottenere l’unità fa leva sullo scatenamento degli “spiriti animali”.Potrebbe apparire difficile conservare l’unità di uno schieramento politico con un simile programma, ma la sua coesione regge sul pilastro della necessità di reagire con determinazione contro l’avversario, ossia contro quei ceti sociali che non hanno le risorse per partecipare individualmente alla lotta per l’arricchimento (o per la sopravvivenza) e che per questo possono inclinare verso la rivendicazione di una “società” che abbia cura anche di loro.Questo, e non altro, è il senso dell’anti-comunismo che Berlusconi sbandiera sistematicamente. Non c’è bisogno che esista qualche soggetto politico che si dichiari comunista, è sufficiente la paura di sommovimenti sociali che esigano una ripartizione della ricchezza socialmente prodotta applicando criteri appena diversi da quelli dell’appropriazione individualistica.Per ora il rischio è remoto, ma viene tenuto costantemente in caldo con l’alimentazione dell’ossessione securitaria e della ricerca dei capri espiatori (non c’è bisogno di creare artificialmente gli episodi più o meno criminali, basta aspettarli, tanto, statisticamente, è inevitabile che prima o poi avvengano, basterà enfatizzarli nei tempi e modi appropriati), e poi c’è il grande strumento, tradizionale da sempre per il potere (giunto all’apogeo con il fascismo-nazismo) della mistificazione.Per gli esempi del genere si può attingere in abbondanza al patrimonio di centro-destra (e centro-sinistra). Un attentato, per esempio, è un “crimine” (magari contro l’umanità), mentre un raid aereo che ammazza molte più persone è un’“operazione militare”, quando non “umanitaria”. Oppure, altro esempio, gli alfieri del “meno stato, più mercato” che sostengono, ora, l’intervento dello stato in economia come unica salvezza (cercando di far dimenticare che il “meno stato” di ieri voleva dire “meno Welfare” per dirottare risorse alle imprese e il “più stato” di oggi vuol dire “ancora più risorse a imprese e banche”). Oppure ancora il Tremonti furia liberista di ieri (con l’invito persino ai pensionati a ipotecarsi la casa per godersene il valore prima della dipartita) e inventore di termini da neo-lingua orwelliana oggi (il “mercatismo”) per prendere le distanze dai disastri di cui lui stesso è stato complice e artefice. Eppure, come si è visto, nessuno ride.E nessuno ride neppure quando i lavoratori di Alitalia, e non le rotte Roma-Albenga del ministro Scajola o la liquidazione di Cimoli (8 milioni di euro) o l’assistenzialismo al “progetto Malpensa”, vengono rappresentati come responsabili del dissesto della compagnia. A quando la dichiarazione che responsabile del disastro economico e della chiusura di molti esercizi commerciali non è il livello minimo del monte-salari, bensì i consumatori riottosi?
C’è, allora, il rischio di un ritorno al fascismo?
Chi si limita a considerare del fascismo solo l’aspetto abolizionista della democrazia formale, può stare tranquillo. Al momento non è messa in agenda da alcuno dei soggetti istituzionali e politici che si affannano a salvare il capitalismo e, nello specifico, l’Italia capitalista. Ciò, però, non toglie, che del fascismo siano riprese e aggiornate molte fondamentali lezioni. Approfondire l’analisi del fascismo storico può, di conseguenza, aiutare ad impostare anche la lotta contro gli attuali apprendisti dei suoi insegnamenti. A condizione che si rifletta su tutto il fenomeno fascista, abbandonando lo stereotipo che abbia avuto come unica caratteristica (o come caratteristica fondamentale) quella di abolire la democrazia.La costruzione di Tremonti è la più coerente e aggiornata ripresa delle lezioni storiche che il fascismo ha tramandato alle classi dominanti. È un equilibrato miscuglio di elementi in grado di combinare le esigenze capitalistiche di contenimento delle esplosioni sociali con quelle di rilancio degli interessi nazionali (in un quadro europeo) per la salvaguardia, in generale, del sistema capitalista e del prelievo che l’insieme dell’Occidente effettua sulla produzione mondiale tramite la trasformazione della ricchezza materiale in finanza e l’esercizio del predominio militare, e, in particolare, dell’italietta sempre più declinante ed emarginata dai grandi flussi finanziari necessari ad operare il prelievo.Nonostante la coerenza, la lucidità e la logica, questa costruzione ha dinanzi a sé diversi ostacoli.Alcuni sono interni allo stesso schieramento politico e sociale di riferimento. Conciliare la necessità di una rigenerazione etica dello stato con un personale politico il cui principale scopo è l’arricchimento proprio e del circuito amicale/familiare è un esercizio alquanto improbabile. Questo fatto, d’altronde, non si può imputare unicamente alla incapacità di Berlusconi di suscitare adesioni politiche fondate su una spinta ideale e non solo su interessi affaristici. Il fatto è che tutte le classi possidenti tendono, nel momento dato, a concentrarsi esclusivamente sull’arricchimento individuale, avendo esse stesse scarsissima fiducia su un rilancio stabile e di lungo periodo di una crescita generalizzata con caratteristiche anche solo lontanamente paragonabili a quelle del trentennio successivo alla seconda guerra mondiale. Ma una politica nazionalistica può fare a meno di una qual certa coesione sociale? E la coesione sociale si può ottenere senza, almeno in parte, smussare l’egoismo individuale delle classi possidenti? Nel ventennio l’acuta paura di un soggetto politico che ne minacciava pesantemente i privilegi determinò una maggiore coesione “nazionale” che mise da parte le punte più estreme di individualismo accumulatore. Per ora opera una minaccia oscura, non ancora una minaccia palpabile contro cui reagire.Inoltre, molti degli elementi che secondo Tremonti sarebbero necessari per fondare una comunità nazionale con un precisa identità trovano ostacoli dentro il suo stesso schieramento. Si veda, per esempio, la verve con cui Tremonti descrive i fondamenti di una rigenerazione dei rapporti familiari: “Contrastare l’idea post-moderna della “famiglia orizzontale” che… sublima la cultura del consumismo, consente di passare, come su una piattaforma girevole, dal consumo delle cose al consumo dei rapporti, delle relazioni e dei sentimenti, in nome della nuova ideologia delle liberalizzazioni… è sufficiente fermarsi alla sala anagrafe per fare shopping giuridico, per consumare al banco un prodotto tipico di questo tempo, immersi come moltitudine nella solitudine dell’effimero…. Un prodotto a bassa intensità morale… senza fastidiosi vincoli e doveri. A questa visione si oppone, e francamente va opposta, una visione antica e forte della società, fatta da principi e da doveri” pag.87/88). Il palinsesto e i programmi del network del suo diretto capo dovrebbero essere radicalmente sconvolti!Ugualmente, è molto difficile tenere in piedi una pace sociale “interna” con proiezione della rabbia nella mobilitazione verso l’“esterno” ricorrendo solo alla riproposizione dei valori identitari e alla sussidiarietà. Qualcosa bisognerà pur concedere sul piano economico. Coi tempi che corrono, miglioramenti generalizzati sono da escludere. Al massimo ci si può impegnare a rallentare l’impoverimento dei ceti medio-bassi. Ma anche questo è difficile da attuarsi in modo egualitario nell’insieme del paese, senza intaccare i trasferimenti statali al profitto e il processo di ampliamento dei settori profittevoli ai danni di quelli statali. Una manovra del genere si può, al massimo, prospettare nelle aree “forti” del paese, riservando alle altre un trattamento differenziato. La riduzione dei trasferimenti statali al Sud potrebbe essere compensata con premi per la dislocazione di grandi strutture fortemente inquinanti (ri-gasificatori, discariche, inceneritori, magari anche centrali nucleari) per foraggiare con le relative prebende una parte almeno del ceto medio parasssitario e un ceto politico adeguato a tenere sotto controllo una forza di lavoro di riserva, fortemente svalutata, cui offrire impieghi di risulta nelle attività produttive e dei servizi del Nord o per qualche delocalizzazione di aziende italiane o straniere. Insomma un’oculata applicazione di federalismo territoriale e classista.Il federalismo di Tremonti non preconizza, al modo di Bossi, la costituzione di micro-stati, ma non per questo contiene meno rischi di disunione del tessuto nazionale.Dal suo punto di vista una frammentazione nazionale potrebbe essere compensata dalla creazione di un centro statuale forte sul piano europeo. Ma i ritardi che l’Europa accumula lungo la strada della costituzione statale unitaria potrebbero vanificare il desiderio. Sul punto gli viene incontro la politica di Berlusconi che cerca di accelerare la costituzione di uno stato forte centralizzato attorno alla figura del “presidente con pieni poteri” anche per cercare di contrastare la tendenza alla frammentazione che non è solo rappresentata dalla Lega Nord, ma che ha infettato profondamente il suo stesso elettorato del Nord e tutti i capi locali del suo partito, oltre che i rappresentanti del Nord del Pd. Sotto questo aspetto la tenuta unitaria dell’Italia è sempre più a rischio e viene ulteriormente incrinata dall’approfondirsi della crisi. Si veda, per esempio, la partita che s’è giocata sui fondi per gli ammortizzatori sociali: quelli destinati dall’Ue alle zone arretrate, in buona sostanza al Sud, sono stati dirottati alla cassa integrazione, che, dato il diverso sviluppo industriale, è utilizzata soprattutto al Nord. Ancora più significativa è la questione Malpensa, che vede a sua difesa schierati compattamente tutti i partiti lombardi, incuranti del fatto che la scommessa Malpensa abbia già determinato il fallimento dell’Alitalia, costretta a deficit impressionanti per tenere in vita l’hub varesino, e incuranti del fatto che un rilancio di Malpensa/Milano può avvenire solo a spese di Fiumicino/Roma (salvo qualche cretino che crede che l’attività di Lufthansa sposti a Malpensa viaggiatori di Francoforte…). Ma il massimo della follia localistica è dato dal fatto che il presunto “compatto Nord” mentre dichiara di voler difendere Malpensa non riesce ad eliminare neanche la concorrenza che fanno a Malpensa i vari aeroporti dislocati a poche decine o centinaia di km da esso. Potenza del federalismo!Il progetto centralizzatore di Berlusconi potrebbe, dunque, essere sconfitto non da un’opposizione “democratica”, ma da una de-centralizzazione federalistica, con conseguente frammentazione del paese in micro-stati autonomi e confliggenti (il conflitto vero e proprio può iniziare immediatamente dopo il “federalismo fiscale”, allorquando diverrà necessario ripartire pro-quota il debito pubblico nazionale pregresso…do you remember Yugoslavia?), ma, a loro volta, non meno centralizzati e autoritari.Anche per quanto riguarda l’Europa, la costruzione tremontiana incontra notevoli ostacoli. Un’accelerazione della costruzione europea è possibile, per il nostro, solo sulla base dell’assunzione del compito di rilancio europeo anti-Cina e anti-Terzo Mondo, sostenuta da una mobilitazione nazional-europeista delle masse, ricambiate da una promessa futuribile di benessere e scarsissimi riscontri sul piano immediato. Ma, al momento, paesi importanti come la Germania e la Francia, avvertono molto meno dell’Italia l’esigenza di scatenare un confronto acceso con la Cina, e, in più, come abbiamo visto, anche gli Usa hanno, al momento, necessità di stabilire con la Cina un compromesso per uscire dalla crisi attuale e, non si può escludere che cerchino, addirittura, di stabilire un compromesso di lungo periodo con una sostanziale gestione del mondo “a due”, una “Chimerica” in grado di preparare nuove esplosive contraddizioni.D’altra parte, la crisi in atto mette a dura prova la stessa tenuta unitaria dell’Europa (e dell’euro). La proposta di “bond europei” formulata da Tremonti è stata fatta cadere dalla Germania, evidentemente poco interessata a fare sacrifici per fronteggiare le situazioni debitorie altrui.Sta, dunque, ritornando il fascismo?Crediamo di aver fornito degli argomenti solidi per sostenere che non solo non siamo di fronte a un ritorno sic et simpliciter del fascismo storico (cosa che chiunque comprende), ma che si stia fucinando una risposta, dall’“alto” e “dal basso”, che riprende molte delle fondamentali lezioni del fascismo e le attualizza alle esigenze del momento per un obiettivo che è molto simile a quello che il fascismo perseguiva: salvare il sistema capitalista dal rischio di catastrofe, ieri per mano di un avversario riconoscibile e dichiarato (il comunismo), oggi da parte di un avversario ancora non visibilmente costituitosi, ma che potrebbe sorgere dall’approfondimento di molte istanze, pulsioni, movimenti, già delineatisi a scala mondiale e che l’incedere della crisi economica potrebbe potentemente favorire. E, in quest’opera di generale salvataggio, salvare anche il singolo paese e preservarne la capacità di attingere sul mercato mondiale quel prelievo di profitti che possa consentire alle classi possidenti di conservare i loro privilegi e le prospettive perenni di accumulazione e arricchimento.Dobbiamo ora porci la seconda domanda: come questo processo può essere contrastato? Bilancio dell’antifascismo Il fascismo storico fu contrastato all’inizio dalle forze resistenti dei socialisti e dei comunisti, con divisioni e indecisioni. I primi privilegiarono, da subito, l’invocazione al ritorno della democrazia e la perorazione allo stato affinché riacquisisse il monopolio della forza reprimendo la violenza fascista. I secondi cercarono, inizialmente, di opporre al fascismo una resistenza di massa che non rifuggiva il terreno dello scontro violento, che i fascisti privilegiavano essendo consapevoli di poter contare sull’aiuto e la connivenza dello stato nell’aggressione ai comunisti e alle loro organizzazioni. La resistenza dei comunisti non aveva come obiettivo “il ristabilimento della democrazia” e della “legalità dello stato”, ma era la continuazione della battaglia per la rivoluzione sociale. Per il Pcd’I dei primi anni dalla fondazione, il fascismo non era, infatti, una particolare forma di potere di cui disfarsi prima di poter riprendere la lotta contro il capitalismo, ma era la forma specifica che il potere politico assumeva in quel frangente proprio per difendere meglio il capitalismo, scosso dalle rivolte proletarie e messo in crisi dalle conseguenze economiche, finanziarie e sociali del primo conflitto mondiale. Successivamente, con le “svolte” e “contro-svolte” staliniane, legate al prevalere in Unione Sovietica dell’esigenza di difendere il paese (ammantandolo della mitologia di “patria del socialismo”) rispetto a quella di continuare a contribuire alla rivoluzione mondiale, anche i comunisti italiani (non senza resistenze, in primis di Bordiga, il fondatore del Pcd’I) cominciarono ad adeguarsi all’idea che il fascismo fosse una forma “particolare” di cui disfarsi per tornare a degli equilibri democratici, per definizione ritenuti più favorevoli all’organizzazione di massa e alla lotta per una società socialista.Il fascismo sconfisse tutte le resistenze iniziali con metodi sbrigativi (oltre a centinaia di comunisti e proletari furono uccisi anche esponenti socialisti come Matteotti) e si garantì circa vent’anni di potere senza una significativa opposizione politica e sociale. Una resistenza significativa si dette solo a partire dal ’43, con scioperi di massa nelle fabbriche prima ancora che con la costituzione delle organizzazioni partigiane.La resistenza post-’43 fu qualcosa di molto complesso, non riducibile alla sola lotta armata e non identificabile unicamente con il programma di “ritorno della democrazia” e di “liberazione nazionale”. Non di meno, l’uscita dal fascismo venne ritenuta realizzata allorquando le regole democratiche furono ristabilite, tornarono a formarsi partiti e sindacati e furono celebrate elezioni pluri-partitiche.Così come Tremonti e la destra riprendono dal fascismo gli insegnamenti essenziali, possono i loro oppositori riprendere gli insegnamenti dell’anti-fascismo?Oltre sessant’anni di democrazia presentano alle classi sfruttate un bilancio in due fasi. Nella prima i risultati sono stati sostanzialmente positivi in termini di avanzamento economico, sociale e politico, anche se solo grazie a lotte spesso violentemente represse dallo stato democratico, con tutti i mezzi, “legittimi” e meno. Nella seconda i risultati sono stati del tutto negativi. La democrazia ha conservato il linguaggio riformista, ma ne ha, con opera lunga e paziente, invertito il senso: le riforme sono diventate il nome delle liberalizzazioni e dello smantellamento delle garanzie sociali conquistate con duri sacrifici.La democrazia ha fallito come sistema da utilizzare per il passaggio a una società più giusta ed egualitaria, ma ha fallito anche come forma di gestione dell’esistente in grado di assicurare un certo equilibrio sociale.I parlamenti sono diventati le casse di risonanza dell’ideologia tambureggiante del mercato, incapaci di costituire un benché minimo argine alla diffusione di politiche economiche e sociali che mentre promettevano un vuoto benessere a tutti, favorivano il diffondersi delle logiche più estreme del capitalismo in ricerca affannosa di profitti e della destrutturazione del compromesso sociale che aveva caratterizzato i primi decenni del secondo dopo-guerra.Lo svuotamento di ogni potere reale delle strutture elettive è avvenuto in un quadro di potente centralizzazione del potere politico reale, non solo nelle mani dei governi e di organizzazioni finanziarie, politiche e culturali trans-nazionali, ma soprattutto nelle mani di un programma politico-ideologico che mette la libera attività economica privata al di sopra di tutto e vuole trasformare definitivamente ogni essere umano in “imprenditore” di sé stesso, in concorrenza permanente con tutti gli altri esseri umani, anche solo per conquistarsi il minimo indispensabile alla sopravvivenza sua e della propria famiglia (unica istituzione sociale, assieme alla Chiesa, che la destra riconosce meritevole di protezione). A compimento di questo lungo processo, non a caso, il parlamento, come l’insieme della “politica”, sono diventati unicamente un’opportunità come un’altra per consentire a una minoranza di avere occasioni di arricchimento e di prestigio, alla stregua di una lotteria che suscita, al più, invidia. Una lotteria che si vince solo se si è sufficientemente proni ai desideri di chi tiene il bandolo della matassa. Se Caligola nominava senatore il suo cavallo, Berlusconi nomina parlamentare o ministro chi gli assicura cieca fede. Ma anche a sinistra la degenerazione non ha avuto limiti, sia nei democratici di sinistra che nei sinistri “alternativi”, finiti come Bertinotti vittima stomachevole dei salotti del puro chiacchiericcio, o come Diliberto a difendere il privilegio del barbiere a prezzi scontati come prerogativa delle guarentigie parlamentari, ebetamente ignaro di come questo confermasse nella coscienza popolare il ben noto assunto della casta privilegiata e auto-referenziale.Questo percorso degenerativo ha preparato il terreno (e il consenso diffuso) alle attuali iniziative di Berlusconi per trasformare definitivamente le aule parlamentari “sorde e mute”, piene di imbelli parassiti, in agili strumenti di approvazione delle scelte e delle decisioni del governo che per raccogliere l’opinione del popolo non ha certo bisogno di stare ad ascoltare i loro logorroici e vacui discorsi.Ma costringe anche tutti gli oppositori attuali (e quelli che presumibilmente, lo saranno in futuro) a domandarsi se un movimento di resistenza possa fondarsi sull’obiettivo del “ripristino della democrazia”.Si tratti di un ritorno del fascismo o di una sua ri-generazione modernizzata e attualizzata, è, ormai, inevitabile porsi il quesito se sarà possibile opporvisi vantando i meriti di un sistema “democratico”, o se si dovrà affrontare insieme la forma del potere e il contenuto, l’esercizio del potere e i suoi scopi, gli assetti politici e la forma sociale di produzione e riproduzione della vita di ognuno e dell’umanità nel suo insieme. Dall’Italia al mondo Prima di provare ad accennare ai problemi che sono intorno al quesito di come contrastare la nuova forma del potere politico in uno con le nuove forme che emergono di potere economico, dobbiamo, però, aprire una breve parentesi sulle sorti del pensiero tremontiano, che, come il fascismo negli anni ’20, non parla alla sola Italia, ma all’intero mondo.La ricetta del commercialista valtellinese, infatti, pur incontrando ostacoli, contiene una sua intrinseca logicità, e al di là delle sorti immediate sul piano “interno”, rientra, con buoni fondamenti, tra le ipotesi all’ordine del giorno sul piano internazionale. Prendiamo come esempio gli Usa.La crisi finanziaria trascinatasi per un anno e, alfine, esplosa nell’estate del 2008, chiude il ciclo della globalizzazione neo-liberista. Tra le macerie rimaste sul terreno c’è anche l’unilateralismo Usa. Il fallimento del “gendarme del mondo” si rivela sotto il duplice aspetto, militare ed economico-finanziario. La sua vittoria è precaria in Iraq come in Afghanistan. Le accelerazioni contro Iran e Russia (via Ossetia del Sud) si sono infrante contro la resistenza delle vittime e la riluttanza dei partner. La crisi finanziaria, che le accelerazioni belliciste avrebbero più facilmente scaricato altrove o, per lo meno, rimandato, è, invece, esplosa in modo deflagrante nel cuore di Wall Street, facendo crollare come un castello di carta il “modello” economico e finanziario della “mano invisibile del mercato” sostenuta dal guanto d’acciaio dei bombardieri e delle porta-aerei.Se l’onnipotenza militare è stata incrinata dalle resistenze irachene ed afgane, quella finanziaria è stata preparata dal rifiuto crescente dell’America latina, dell’Asia, e persino dell’Africa, a fungere da cornucopia dei flussi finanziari diretti verso il vertice della piramide nord-americana. I movimenti di lotta iniziati nella seconda metà degli anni ’90 hanno determinato quasi ovunque politiche statuali meno assertive nei confronti di Wall Street, e un distacco crescente dalla dipendenza dal FMI e dalla BM. La riduzione dei flussi finanziari dal resto del mondo (proprio nel momento in cui la fame di essi cresceva a dismisura nell’Occidente finanziarizzato) ha scosso le basi della piramide finanziaria su cui la crescita nord-americana si fondava e, per la prima volta dal secondo dopo-guerra gli Usa non sono riusciti a far esplodere la bolla finanziaria altrove. Vi erano riusciti con il Giappone negli anni ’90, con il Sud-est asiatico alla fine del secolo, poi con la Russia e l’Argentina. Stavolta il cerino è rimasto a Wall Street ed ha acceso un bel petardo!Affermare che gli Usa sono in pieno declino della potenza economica, finanziaria, militare e politica non è più un’affermazione azzardata. È una semplice presa d’atto. Si prepara, così, un mondo dominato da una delle varie versioni del multilateralismo? Accetteranno gli Usa di essere una “nazione normale” che si colloca su di un piano di parità rispetto a tutte le altre? O, per lo meno, accetteranno di condividere il potere mondiale in concertazione e cooperazione paritaria con una pluralità di grandi potenze?All’immediato è molto probabile che gli Usa debbano abbassare la voce almeno di un tono, dedicandosi alla cura delle ferite interne e internazionali che si sono aperte negli ultimi anni. Ma sul medio-lungo periodo la prospettiva è condizionata dalla posta in gioco. Non si tratta, infatti, soltanto di qualche frazione di profitto in più da lasciare ad altri, quanto dell’american way of life, che per la maggioranza degli americani vuol dire la casetta, la macchinona e la libertà incondizionata di consumo, ma per le classi possidenti vuol dire accumulare ricchezza prelevando da ognidove vi sia produzione, commercio, risorse naturali e rapporti sociali (scuola, sanità, ecc.) suscettibili di essere convertiti in danaro. Mentre i primi potranno accettare di fare rinunce, per le seconde il problema è, persino, più drammatico.Il sistema capitalista non può fare a meno del processo di valorizzazione del capitale e l’eccedenza di capitale creata ha preso la forma di una massa incontenibile di titoli di credito che esigono la propria valorizzazione, per la quale le basi produttive industriali si rivelano anguste e ristrette al punto che il capitale ne rifugge per concentrarsi in settori in cui investimenti ridotti offrono rendimenti elevati. Un sistema che, ovviamente, non può dare “tutto a tutti”, ma che è forzatamente costretto a una feroce concorrenza.D’altra parte questa way of life ha adepti in tutto l’Occidente, e tutto l’Occidente (di sicuro le classi possidenti) corre, ora, il rischio di rimanere vittima di un grande sconvolgimento delle gerarchie del mercato, o, peggio, dell’emergere di soluzioni produttive e di scambio che facciano a meno del mercato e, dunque, della trasformazione in ricchezza monetaria della produzione. Difendere il capitalismo e difenderne la vigente gerarchia è, per gli Usa, un tutt’uno (per altri le due cose cominciano a non essere interpretate più come inestricabilmente intrecciate…). Con quali mezzi gli Usa potranno difendere il sistema mondiale capitalistico e il proprio predominio in esso? Quelli di sempre: potenza delle armi e dominio politico.Per esercitare l’una e l’altro, però, è necessario procurargli il supporto di un sostegno convinto, organizzato e disciplinato della propria società. Ciò vuol dire anzitutto ri-motivare il proprio popolo e rinnovare l’immagine appannata dall’ultimo decennio di sconfitte e fallimenti.L’establishment che appoggia Obama gli affida questa estrema missione: riconsolidare la coesione interna, rimettendo in moto in senso nazionalistico le sue minoranze più emarginate e oppresse (le uniche, peraltro, cui attingere per alimentare la “carne da cannone” per le attuali e future guerre) e ridare lustro all’immagine internazionale del paese allo scopo di rifondare su nuove basi la sua supremazia. Se vi riuscirà, sarà possibile impugnare con maggiore veemenza le armi di sempre, per prepararsi a una battaglia “per la vita o per la morte” contro concorrenti globali o regionali che ne mettessero in discussione la prevalenza o contro movimenti globalizzati capaci di scuotere dalle fondamenta il sistema.Quanto dell’armamentario tremontiano sarà utile anche oltre-oceano? A ben vedere, lì non hanno certo bisogno di leggere Tremonti per imbastire un quadro di “rilancio” interno e internazionale che si strutturi attorno a una mobilitazione nazionalista delle masse più “profonde”, tuttavia, molti degli argomenti obamiani sembrano richiamare quelli tremontiani.Ciò non toglie, a ogni buon conto, che nella politica verso le classi sfruttate Obama dovrà cercare di mettere un po’ più di “ciccia” di quella che vi riversa Tremonti. Non è differenza da poco e si tratterà di vedere se e in che modo le classi proletarie americane prenderanno sul serio le avances obamiane e si disporranno, anche a partire da queste promesse, su una base propria, autonoma rispetto alle esigenze della super-potenza americana e delle classi possidenti. Come contrastarlo? Torniamo alla seconda domanda: come contrastare questo processo?Cominciamo da una constatazione: l’unico ostacolo che questa nuova destra non ha è quello della sinistra.Quella parlamentare non solo rifugge dalla denominazione stessa “di sinistra”, ma non è in grado (né vuole…) di imbastire alcuna credibile alternativa. Ha pienamente ragione Berlusconi a vantarsi di dover governare in assenza di opposizione. Il problema non è organizzativo, né di mancanza di credibili leaders, ma riguarda le opzioni di fondo che questo schieramento ha, ormai, stabilmente scelto. Dall’abbandono del “salario come variabile indipendente”, all’idolatria del mercato come scelta obbligata per promuovere la “crescita economica” esaltata come unica strada per potere esigere anche un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per i ceti non possidenti; dal “partito di opposizione” a quello che “governa stando all’opposizione”, a quello “di lotta e di governo”, la parabola si è, alfine, conclusa con il partito (poco partito e tanto “leggero”) di governo anche quando sta all’opposizione. Più ancora delle scelte tattico-strategiche e organizzative il percorso di questa parte di ex-sinistra è stato di completa immedesimazione con le logiche del mercato e del capitalismo, sposate, per di più, nella fase in cui si ribadiva con veemenza la necessità che esprimesse liberamente i suoi istinti animali. La parabola ha prodotto risultati devastanti nella struttura organizzata della classe operaia, portandola progressivamente a contare sempre meno sulla sua organizzazione di lotta e a subordinare qualsiasi sua rivendicazione all’andamento delle imprese e del sistema nel suo complesso. Nel corso di questa sua evoluzione l’iniziativa più costante di questa parte della sinistra è stata quella di contrastare le “rigidità” organizzative, sindacali e politiche della massa dei lavoratori, dando un contributo fondamentale a de-strutturare la sua stessa base sociale di riferimento. L’inseguimento dei ceti “moderati” e dell’appoggio dei poteri forti ha avuto un certo successo solo quando questi avevano bisogno di una forza che indebolisse dall’interno un movimento sociale e politico che accumulava forza tale da spaventare i “manovratori”. L’ultima esperienza del genere è stato il governo Prodi, promosso e sostenuto finché si trattava di contrastare il movimento iniziato a Genova nel 2001 ed estesosi nella lotta contro l’abolizione dell’art. 18 e il governo Berlusconi 2001/2006, nonché in mille forme diffuse sul territorio di resistenze alle distruzioni ambientali e sociali. Conseguito l’obiettivo di de-potenziare la carica politica di questo movimento, a Prodi e alla sua clownesca compagine è stato dato il “ben servito” senza tanti complimenti e senza alcun ringraziamento.La sonora lezione delle elezioni del 2008 è stata appresa talmente con profitto dal Pd da convincerne gli esponenti ad… accelerare sulla strada di sempre. Oggi gareggiano con Berlusconi a disegnare scenari di uscita dalla crisi che hanno lo stesso identico segno: salvataggio della bolla speculativa, rilancio della competitività delle imprese e iniezioni di droga per far ripartire la “crescita economica”, con, al più rispetto al governo, un tanto di micragnosa elemosina a favore dei “più svantaggiati”.Nessun dubbio è possibile nutrire sul fatto che questa sotto-specie di opposizione non può che continuare a essere la fotocopia sbiadita della destra. Né dubbio alcuno ci può essere che l’elettorato gli preferirà pur sempre l’originale. Di questo passo c’è il rischio che il Pd non abbia più la capacità di intercettare, per piegarli, eventuali forti movimenti sociali che dovessero riemergere sotto la spinta dell’acuirsi della crisi. Ma per questo, come si è visto, la nuova destra si va attrezzando in proprio, sia con la predisposizione di più efficaci misure di repressione, sia allenandosi a “internalizzare” i dissensi. Sullo sfondo, d’altronde, resta sempre la possibilità di sospingere le contraddizioni sociali verso lo sbocco della contrapposizione “federalista”, fino all’estremo limite della separazione in micro-stati. La sinistra ex-parlamentare non sta meglio: impegnata a leccarsi le ferite, stordita tra l’incapacità di affrontare i quesiti profondi che la sua parabola storica lascia sul tappeto e l’irrefrenabile coazione a ripetere l’itinerario riformista-statalista che l’ha portata alla sconfitta. La denuncia del rischio di un ritorno del fascismo potrebbe, in astratto, possedere una carica seduttiva sufficiente a rilanciare lo spirito militante di quanti –non pochi- ripongono speranze nel suo riscatto. Ma l’argomento funziona poco per mobilitare vecchi militanti e simpatizzanti, e nulla per suscitarne di nuovi. L’antifascismo è stato elemento costitutivo fondamentale di grossa parte della sinistra, ma la sua declinazione in chiave esclusivamente democraticista ha contribuito a determinarne il declino. La democrazia da mezzo è divenuta fine, lo stato da strumento di trasformazione è divenuto feticcio, il capitalismo da sistema da abbattere è divenuto il sistema oltre il quale è impossibile andare, e che si può al più cercare di moderare e correggere in un senso più umano, più democratico. Tutto ciò ha contribuito a concimare il terreno per la destra che, oggi, svela la sostanza della democrazia come processo esclusivamente elettorale per confermare il potere politico nelle mani di chi detiene già quello economico, riduce lo stato alla sua essenza di monopolio della forza a difesa del sistema della proprietà privata e del privilegio per chi possiede qualcosa in più della semplice capacità lavorativa, agita la difesa del capitalismo come difesa del sommo bene comune.Ma, mentre a sinistra si continua a rimestare la stessa minestra, combinando i medesimi ingredienti, sia pure con intensità diversa a seconda delle componenti e delle tendenze, il quadro materiale che sorreggeva lo schema precedente è andato progressivamente mutando. Il punto centrale di questo mutamento non è la dichiarata scomparsa del proletariato industriale (di cui, invece, quanto a condizioni di lavoro e di salario, c’è una moltiplicazione a scala internazionale e nazionale), né il variare della composizione di classe a favore del lavoro cognitivo, ma soprattutto l’erosione della base del compromesso tra capitale e lavoro: il mantra del comune interesse allo sviluppo perde, di giorno in giorno, i suoi appigli reali. Se per svariati decenni “crescita” (dei profitti) e incremento del benessere materiale sembravano procedere di pari passo, procedono, ormai, in modo sempre più divaricato: la “crescita” può inverarsi solo con un arretramento delle condizioni dei lavoratori. Anzi, anche questo non basta più: per sostenere la crescita bisogna sommare al sacrificio produttivo anche quello sul terreno ri-produttivo, della propria singola esistenza e dell’esistenza dell’ambiente naturale e dei rapporti umani.Il mutamento sta determinando uno spostamento del precedente fulcro della battaglia.Prima, e per un lungo periodo, esso era centrato, da un lato, sul quanto si riusciva a strappare alle imprese in termini di salario e condizioni di lavoro, e, dall’altro, su quanto si riusciva a condizionare, utilizzando la leva dello stato, la politica delle imprese e ad imporre l’utilizzo in servizi pubblici (ossia in salario indiretto) di almeno una parte della produzione sociale. L’organizzazione operaia, favorita dall’estensione della grande impresa basata su grandi unità produttive, ha dato vita a forme sindacali e politiche che le hanno reso possibile esercitare una notevole forza sugli assetti politici, anche perché le consentiva di agire da forte polo di attrazione per i settori di proletariato confinati in unità aziendali più ridotte e per i ceti sociali che vedevano la condizione operaia come una leva di riscatto da condizioni peggiori oppure come una forza su cui appoggiarsi per ottenere progressivi miglioramenti (in Italia, la stagione delle “riforme di struttura”).L’esercizio della forza operaia, derivante dalle condizioni di collocazione nella produzione sociale, e la capacità di costituire reti di alleanze, hanno consentito di raggiungere risultati rilevanti, sempre e solo grazie alle mobilitazioni, talvolta dure. Non di meno questo svolgimento è stato aiutato dal fatto di muoversi su un terreno favorevole, determinato dal quadro di continuo sviluppo delle industrie e dei mercati di un capitalismo, che beneficiava, dopo le distruzioni belliche, di una lunga fase di crescita.Con un procedere a volte lento ed a volte con repentine accelerazioni questo meccanismo si è, alfine, come abbiamo già accennato, interrotto. La grande fabbrica si è frantumata in una miriade di centri produttivi lillipuziani. Il processo di centralizzazione del potere economico non si è fermato, ha subito anzi una potente accelerazione, concentrandosi nei centri decisori della finanza che, intrecciati con le grandi imprese trans-nazionali, dominano ferreamente tutti i settori della produzione e del consumo, e sottomettono al loro controllo e al loro prelievo di profitti tutta la produzione sociale e ogni singola unità “indipendente” che la fabbrica. Ciò ha indebolito alle radici la forza di coalizione della classe operaia e, con essa, di ogni altro movimento sociale che vi si collegava. Questo processo di parcellizzazione della produzione è stato accompagnato da una sostanziale stasi della produzione industriale e, anzi, dal manifestarsi crescente di una crisi di sovrapproduzione non solo nei settori di punta (come l’auto) dei decenni della crescita. L’evoluzione progressiva delle condizioni dei lavoratori si è, insomma, risolta nel suo contrario, ma nel loro contrario si sono risolte anche le condizioni generali di sviluppo all’interno delle quali si realizzava.Se il fulcro del problema era precedentemente il miglioramento delle condizioni di vita all’interno di un generale sviluppo del sistema, oggi comincia a palesarsi sempre più drammaticamente attorno al tema della sopravvivenza, richiamando in primo piano, in modo sempre più pressante, la domanda: può la vita singola, quella sociale, della specie umana e della natura continuare a dipendere per la sua sopravvivenza, per la sua ri-produzione, dalla crescita degli affari e del profitto, dal sistema delle imprese e del denaro?La contesa sembra astratta, filosofica, in realtà comincia a manifestarsi soprattutto sul terreno pratico. Dai contadini indiani in lotta contro la “rivoluzione verde”, dai suburbi dell’America latina alle prese con il problema della sopravvivenza, come dalla rivolta argentina del 2001, emerge l’urgenza di un’organizzazione della produzione per la vita che faccia a meno del sistema delle imprese e dello scambio in denaro. Piccoli focolai prodotti dalla presa d’atto (pratica, prima ancora che di coscienza) che il capitalismo non arricchisce, né sfama, crea al contrario miseria e fame.Nell’Occidente iper-sviluppato il tema si è posto, finora, solo in movimenti (apparentemente) marginali e, spesso, contradditori (la “decrescita”, i tentativi di pratiche di scambio non ossessionate dalla ricerca di guadagno, la sensibilità ai temi del consumo indiscriminato del territorio, dell’ambiente naturale e della vita umana, ecc.). La crisi comincia ad estendere il numero di coloro che sono costretti a porsi la stessa domanda, a cominciare da coloro che perdono il lavoro. Ritrovarlo diventa sempre più difficile. Ammesso che dalla crisi attuale si esca con una “ripresa” più o meno duratura che incrementi le opportunità di occupazione, una seconda cosa comincia ad essere terribilmente chiara: lavoro ci sarà solo per chi contribuisce alla competitività delle imprese, con salari competitivi, intensificato sforzo di lavoro e ulteriori cessioni alla produzione dei propri tempi di vita.La speranza che uno sviluppo del capitalismo si possa tradurre in un miglioramento della vita di tutti si va, insomma, eclissando, e, di conseguenza, si va spegnendo la fiducia in una lotta contro le imprese e lo stato al fine di correggere le distorsioni del sistema indirizzandone lo sviluppo anche a proprio vantaggio.Prima ancora che un nuovo sistema venga “pensato” nella coscienza di massa, urge, però, la necessità di sconfiggere la fame e bloccare la distruzione dell’ambiente di vita e di riproduzione della vita e dei rapporti umani. Anche per il fallimento delle “grandi narrazioni” del ’900, questa esigenza comincia, dunque, a porsi essenzialmente sul piano pratico, della ricerca di soluzioni concrete.Così a Detroit si trasformano in orti collettivi le aree edilizie non edificate per causa del crollo delle aspettative immobiliari, orti si moltiplicano nelle villas miseria del suburbi sudamericani, cresce il numero dei brasiliani che, delusi dall’inurbamento, si uniscono ai Sem Terra per un ritorno all’agricoltura (che sia, stavolta, “senza sfruttamento”). Ma, nell’Argentina della rivolta del 2001, la questione ha iniziato a lambire anche il lavoro operaio, come efficacemente mostra il film The Take di Naomi Klein. In seguito alla “presa” i lavoratori hanno dovuto, comunque, fare i conti, per la sopravvivenza delle aziende “prese”, con le condizioni del mercato, ma, pur tuttavia, il tema si è posto e il suo sviluppo in un senso (verso il mercato) o in altro (senza il mercato) non si può certo imputare ai soli lavoratori che vi partecipano, ma dipende, in ultima istanza, dalle condizioni generali in cui questa lotta si svolge (nel 2001 il problema rimase confinato in Argentina, mentre il mercato continuava a funzionare nel resto del mondo) e, naturalmente, dallo sviluppo di un movimento a scala mondiale in grado di consolidare la tendenza, difenderla e dargli uno sbocco generale.Lo sviluppo sul piano concreto, quindi, può essere (ed é!) un primo passo, ma, da solo, non può realizzare il grande cambiamento di cui c’è bisogno sul pianeta. Per affermarsi come soluzione generale dovrà inevitabilmente affrontare il problema di darsi dimensione e forza politica per affrontare un avversario che, nonostante il suo fallimento storico, non è certo disposto a farsi da parte, ma che per conservarsi è pronto a impiegare tutta la sua potenza distruttiva sul piano politico, ideologico e militare.Anche se insufficiente, quel primo passo è, ciò non di meno, indispensabile, soprattutto perché non si pone come semplice “resistenza”, ma, pur senza “pensarlo” compiutamente, comincia a gettare, in filigrana, le basi di un nuovo sistema: comunità umana contro impresa, cooperazione produttiva contro scambio in denaro, necessità della vita contro il sistema del profitto.Allo stesso tempo inizia a farsi spazio anche un altro problema. La forza propulsiva del capitalismo si affievolisce, le aspettative riposte nel suo sviluppo si dileguano, ma anche il rapporto con lo stato non gode più dei vecchi favori. Si può affidare a lui il compito di ri-organizzare la produzione per garantire la vita di tutti? O bisogna puntare sulle proprie capacità di auto-organizzazione?Si tratta di movimenti e tendenze, al momento, senz’altro minoritari. Non è il caso di costruire su di essi il sogno di immediato rilancio di un movimento mondiale anti-capitalista. Non di meno da esse emergono, in embrione (a prescindere, dunque, anche dagli esiti immediati di questo o quel movimento), gli elementi costitutivi di un nuovo assetto sociale, che se richiama dei lontani parenti li trova nel comunismo di Marx, non certo in quello “realizzato” o preconizzato da tanti suoi apologeti usi a denominare comunismo il proprio keynesismo più o meno “di sinistra”. Non di meno esse sono impegnate a risolvere un problema che non riguarda solo loro, ma tutto il mondo, sia pure, al momento, con profondità diversificata. Produzione contro finanza Anche nella crisi che si è abbattuta sul mondo a partire dall’esplosione della bolla speculativa gli elementi del problema si rivelano con forza. Apparentemente sembra che il crollo della finanza sia avvenuto per un cedimento interno al proprio sistema e che abbia, solo in seguito, scaricato gli effetti negativi sul mondo della produzione. Tutti i governi e le forze politiche si concentrano, di conseguenza, nello sforzo di risanare i bilanci delle banche (scavando voragini nei debiti pubblici), ricreare le condizioni di fiducia negli ambienti finanziari, per rimettere in carreggiata i meccanismi del credito e rilanciare, attraverso essi, il consumo e gli investimenti. Voci (sempre più flebili) della sinistra oppongono a questa una proposta di uscita dalla crisi che privilegi gli investimenti diretti nella produzione, affidando allo stato la funzione di indirizzo e di intervento in prima persona. A questa ricetta viene attribuito il merito di aver risolto la crisi del ’29, ma fu davvero così?La crisi del ’29 ebbe alcuni caratteri simili a quella attuale. Anche allora la causa scatenante fu una bolla finanziaria divenuta gigantesca rispetto alla base produttiva di ricchezza materiale. Allora come adesso la crisi era crisi globale della riproduzione complessiva della società del capitale. Vi è, tuttavia, una differenza molto significativa. Il capitalismo era allora nel pieno del passaggio dalla sussunzione formale a quella reale ed aveva, di conseguenza, un vasto terreno da fecondare per il proprio rilancio. L’incremento dell’applicazione della tecnologia al processo di lavoro avrebbe permesso di ridurre fortemente il “tempo di lavoro necessario” per la produzione delle merci e, al tempo stesso, per la riproduzione della forza-lavoro, dando un nuovo impulso all’incremento del plusvalore relativo. Uguale, se non maggiore, impulso alla produzione di plusvalore avrebbe potuto realizzarsi con l’inglobamento all’interno dell’accumulazione capitalistica di vasti settori di economia non-capitalista. Oggi questi processi si sono pienamente dispiegati e i margini di ulteriore espansione sono sempre più ridotti.Tuttavia, ciò che è degno di nota ai fini del discorso che attualmente ci interessa, è che ambedue le misure sono state impiegate a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale (facendo, peraltro, fare un gigantesco passo avanti alla costituzione del “mercato mondiale”). Anche allora, insomma, si dovette risolvere il problema della svalorizzazione di una parte importante del capitale fittizio che si era ammassato. Il New deal americano, come il nazional-socialismo e il fascismo, riuscirono unicamente a rimandare il problema di una decina d’anni, ma solo la guerra mondiale lo risolse con la distruzione di tutto il capitale fittizio accumulato in ogni sua forma: finanziaria, industriale e, soprattutto, di forza-lavoro umana, consumata dai campi di battaglia, dai bombardamenti sulle città, dalla fame e dalla miseria. Solo grazie a questa distruzione l’economia poté riprendersi e macinare 25-30 anni di “crescita”.Dalla crisi del ’29 non si uscì, quindi, per merito del rilancio produttivo realizzato dall’intervento statale. Se ne potrebbe uscire oggi dalla crisi attuale?Lasciamo ad altra occasione la discussione su questo interrogativo e concentriamoci, invece, sulla domanda che vi è correlata: è possibile eliminare le “escrescenze” della finanza, il capitale fittizio, e conservare solo quella parte di finanza (magari nelle mani dello stato o sotto il suo controllo) indispensabile a permettere la produzione e il suo commercio? È, di conseguenza, possibile separare i due mondi, produzione e finanza, “economia reale” ed “economia di carta”?Nel sistema capitalista la produzione non viene realizzata per soddisfare dei bisogni, ma per valorizzare il capitale con l’acquisizione di un valore aggiuntivo. La soddisfazione del bisogno non è il fine della produzione, ma un mero accidente, per quanto necessario, tanto è vero che il capitalismo moderno è divenuto espertissimo nel conculcare artificiosamente nuovi bisogni per creare mercato alla sua pletorica produzione.Nel quadro dato del capitalismo, e non in un quadro immaginario, come può un’impresa affrancarsi dal dominio della finanza? Quale singolo capitale può sopravvivere solo con i profitti “industriali”?Se guardiamo alla realtà scopriamo che non esiste alcun capitale, piccolo o grande, che non cerchi di integrare i profitti “industriali” con un prelievo sulla massa generale della ricchezza sociale e, in particolare, sui guadagni realizzati mettendo a frutto le risorse naturali, le masse povere dei paesi di scarsa o nulla industrializzazione, e la vita di tutti i cittadini anche dei paesi industrializzati. C’è un solo modo per realizzare tutto ciò: gli strumenti sempre più sofisticati della finanza.Si può discutere se si tratti di avidità “umana” o di una legge connaturata al sistema stesso di produzione e scambio, ma, crediamo, vi possano essere pochi dubbi su questa realtà.Contrapporre la “speculazione finanziaria” alla “produzione” da parte delle imprese non ha, insomma, gran senso. I titoli di carta creati dal capitalismo (non negli ultimi anni, ma nel suo itinerario storico plurisecolare) sono costituiti massicciamente proprio da capitali in origine investiti nella produzione e che, perseguendo il loro fine (la ri-valorizzazione), si sono riversati nell’unico meccanismo che permette di avere come punto d'appoggio della valorizzazione non solo la propria misera base produttiva, ma il mercato mondiale, il mondo intero.Essi sono, ormai, una massa impressionante che esige per la propria valorizzazione una quota crescente di ricchezza mondiale. Nessun governo, nessuno stato, nessuna banca centrale ne decreterà mai la scomparsa. Tuttalpiù se ne farà una limatura (magari attraverso bad banks o analoghi strumenti per scaricarne il costo sul parco buoi dei piccoli risparmiatori, o risparmiatori per necessità come i mutuatari per acquisto di case, e, in ultima istanza a spesa dei salari) e si sottoporranno a “maggiori controlli” e “regole più rigide”, ma non scompariranno, né scomparirà la capacità del sistema di ri-produrli a velocità stratosferica. A meno che una generale guerra distruttiva non ne riduca radicalmente il valore, consentendo una ri-partenza con meno zavorra.La crisi mette in primo piano apparentemente la contrapposizione tra “produzione” e “finanza”, ma la produzione che si contrappone alla speculazione non è quella delle imprese (a loro volta dipendenti dal circuito della speculazione finanziaria, qualsiasi cosa ne pensino i fautori a tempo scaduto di un keynesismo ormai logoro), ma la produzione necessaria alla sopravvivenza vitale dell’individuo e della specie umana in un ambiente naturale che conservi le sue capacità riproduttive e continui a erogare i suoi frutti per la vita umana. In contrasto sono la produzione (per la ri-produzione della vita) e il sistema capitalistico. Superare il capitalismo La necessità di superare il capitalismo smette, dunque, di essere questione di teoria o di ideologia è diviene drammaticamente pratica. Con ciò si aprono prospettive interessanti, ma anche problemi immani, di riflessione, discussione, organizzazione e lotta.La parte maggioritaria delle forze politiche nate con lo scopo di abbattere il capitalismo, si sono convertite alla sua difesa, e s’impegnano con la passione dei neofiti per promuovere la diffusione urbi et orbi del sistema della “libera impresa” con, al massimo, il tentativo di temperarne gli eccessi con qualche legge dello stato, con i richiami all’etica, o (la sinistra ex-parlamentare) con l’invocazione di uno statalismo re-distributivo e vagamente protezionistico. La parte minoritaria della sinistra, conservatasi nel tempo anti-capitalista, è rimasta affezionata a uno schema (proletariato industriale/organizzazione sindacale-partito/presa dello stato) ormai irripetibile. C’è, per molti versi, davvero da ricominciare daccapo.In crisi non è andata, infatti, solo la rappresentanza politica del movimento operaio del ’900 . In crisi, persino più acuta, sono andati anche i rappresentati, a partire dalla classe operaia industriale che è stata, per decenni, il cuore del movimento operaio, delle sue lotte sindacali e politiche e delle sue forme organizzate. I motivi della crisi sono complessi e meriterebbero un’indagine ben altrimenti approfondita dei pochi cenni che possiamo dedicargli in questa sede. Più che un’analisi dettagliata quella che vorremmo introdurre è una domanda aggiuntiva per delineare un nuovo orizzonte di ricerca.Il proletariato industriale pare, in questo momento, quasi completamente afasico, silente, e lo è davvero se si tiene a mente la sua storia di lotte e di organizzazione.Su questa situazione influisce, indubbiamente, la parabola della sinistra che, nel suo inseguimento al mercato, ha sistematicamente cercato di distruggere dall’interno tutte le “rigidità” (salariali, di condizioni di lavoro, di contrattazione collettiva) che fino agli anni ’70 aveva contribuito a realizzare. Dalla “centralità dei lavoratori” si è passati alla “centralità del lavoro”, per finire con la “centralità dell’impresa”, il bene supremo cui subordinare tutto il resto (pur con alcune significative differenze, questa parabola ha coinvolto tutta la sinistra del pianeta, in particolare quella del mondo occidentale).Un notevole influsso vi ha avuto (e vi ha) anche la politica attiva seguita negli ultimi decenni da parte del padronato e dei governi nel frammentare le unità produttive, de-localizzare gli impianti, introdurre elementi di divisione e concorrenza per minare l’unità organizzativa che era stata il presupposto per l’unità sindacale e politica di lotta che aveva portato al ciclo di lotte degli anni ’60-’70 (anche questo è stato un processo avvenuto a scala mondiale).Qualcosa, lo ripetiamo, di ancora più profondo si è, però, modificato nel corso degli stessi decenni: se prima allo sviluppo delle imprese conseguiva un miglioramento (sia pure in proporzione minima) delle condizioni salariali e di lavoro, ora lo sviluppo delle imprese avviene solo grazie a un loro peggioramento.Politica congiunturale suscettibile, prima o poi, di essere invertita o nodo storico del sistema capitalistico?Sia quel che sia, l’equazione secondo cui la lotta di classe veniva assorbita dal capitale senza problemi, grazie alla sua capacità di sviluppare le forze produttive, e svolgeva, anzi, in ultima istanza, la funzione di spinta propulsiva allo sviluppo, non funziona più.Rivendicare più salario e migliori condizioni di lavoro non corrisponde più a un generale sviluppo delle imprese e della società, ma al suo contrario: dinanzi al rivendicazionismo operaio le imprese falliscono o delocalizzano. Con ciò il fattore di scambio con il lavoro viene capovolto: finora hai accettato di farti sfruttare in cambio del necessario per sopravvivere e con la speranza di migliorare il tuo tenore di vita, d’ora innanzi devi considerare un privilegio avere un posto di lavoro, anche se questo non ti garantisce più la sopravvivenza.Questo cambio di paradigma produce un profondo effetto di spiazzamento, che pesa sull’attuale capacità di reazione della massa dei lavoratori, a nostro giudizio, anche più dei primi due aspetti citati. In generale tra i lavoratori prevalgono la speranza che la crisi passi alla svelta e si torni, al più presto possibile, alla precedente situazione e la convinzione che più lunga sarà la crisi, più la ripartenza sarà pagata da loro in termini di salario, di lavoro, di aspettative sociali. In Italia questo sentimento è molto diffuso come testimoniano le difficoltà di mobilitazione della Cgil e dei sindacati extra-confederali, che, pur tra tanti limiti, provano, per lo meno (e, naturalmente, con differenze di impostazione), a costituire un argine agli ulteriori arretramenti. In altri paesi le reazioni sono state, in verità, più partecipate, dando una pregnanza maggiore allo slogan che pure fin dall’inizio ha fatto capolino (“La vostra crisi non la paghiamo”) e, nelle ultime settimane, ha cominciato anche ad apparire un discrimine di classe (le proteste, soprattutto in Usa, contro gli aiuti alla finanza e contro l’avidità dei manager) che in Italia, tranne i tentativi dell’Onda e dei sindacati extra-confederali, sembra argomento tabù.L’effetto di spiazzamento, tuttavia, predomina ovunque e la destra cerca, ovunque, di capitalizzarlo per sfruttare la crisi per assestare un nuovo duro colpo alle capacità di resistenza collettiva sia dei lavoratori sia sui terreni dell’ambiente e della vita, per un rilancio della produzione e dei mercati liberati da ogni ostacolo sociale, politico o, come dice Berlusconi agli anti-inceneritore di Acerra, “ideologico”.La sconfitta del movimento operaio classico non potrebbe essere più radicale (e, tuttavia, potremmo non essere all’ultimo stadio…), e tutti i tentativi di tenerlo in vita, con gli stessi programmi e con le stesse forme, sono, probabilmente, destinati a fallire. Prima ancora che il suo fallimento si consumasse definitivamente qualcosa di nuovo ha cominciato ad emergere, da Seattle ’99 in poi. Al momento anche questo movimento è in difficoltà, ma molti dei temi e degli argomenti che ha elaborato e su cui si è mobilitato, possono essere tranquillamente travasati in un’eventuale ripresa di mobilitazione in tutto il mondo. La domanda lasciata, da quel movimento, sostanzialmente inevasa e che ora torna, invece, a porsi con centralità crescente per ogni attuale e futura resistenza è: quale ruolo il lavoro può avere nella resistenza alla crisi e all’uso che ne viene fatto per rilanciare un meccanismo di sviluppo sotto tutti gli aspetti devastante?La risposta non è semplice, tuttavia, crediamo, che il cambio di paradigma nel rapporto sviluppo/condizioni dei lavoratori possa avere un peso significativo per influenzare il segno e la direzione della resistenza. Con esso, infatti, il rapporto mefitico che ha tenuto il lavoro agganciato al capitale (che aveva, in ultima istanza, caratterizzato tutto il precedente movimento operaio) inizia a sgretolarsi. La crescita di questo non comporta più miglioramenti per la vita di chi lavora, anzi la stessa sopravvivenza non è più il compenso della forza-lavoro erogata all’impresa, ma bisogna, per sopravvivere, erogargliene sempre di più o integrarla in mille modi con altre attività. Ecco perché una domanda radicale comincia a serpeggiare anche nelle nostre società europee, dove l’equazione aveva trovato la migliore realizzazione: perché continuare a sottomettere la mia vita al successo dell’impresa e alla crescita dei mercati e degli affari?La reazione di gioia dei lavoratori Alitalia all’annuncio del ritiro dell’offerta della Cai cos’altro era, se non un grido di liberazione: non ci pieghiamo al vostro ricatto, non vi stendiamo tappeti rossi perché avete la bontà di conservarci il posto di lavoro, ci rifiutiamo di far calpestare la nostra dignità per il misero obolo che ci offrite. La reazione va considerata con tutte le cautele. Si trattava di lavoratori che pensano di possedere delle professionalità ancora spendibili, che ritenevano scarsi i rischi di abbandono della compagnia da parte del governo, e che, anche in caso di abbandono, erano consapevoli che qualche altro acquirente si sarebbe fatto avanti. Ciò nondimeno, la faccia di Berlusconi, dopo l’esplosione di gioia, era livida come non mai, e anche quella di Epifani non era tanto distesa: cosa succederebbe mai se i lavoratori smettessero di sentirsi colmi di gratitudine verso gli imprenditori che graziosamente gli permettono di lavorare?Ha avuto la durata di un flash, i lavoratori sono tornati di nuovo alla logica dei sacrifici per rilanciare l’azienda. Il flash dura un millesimo di secondo, ma produce illuminazione. Chi può escludere che quell’attimo non si sia fissato come un’illuminazione repentina in qualche altro lavoratore succube di analogo ricatto?D’altronde, qualcosa di analogo (e di ancor più significativo) è successo in Romania l’anno scorso. Alle richieste salariali “eccessive” degli operai, la Renault ha risposto minacciando di delocalizzare in Corea. Gli operai non sono arretrati di un millimetro, han fatto i conti in tasca alla Renault e concluso che prima di tre-quattro anni non le sarebbe stato conveniente trasferire lo stabilimento. Nel frattempo, hanno detto, pagate l’“eccesso”!Sciogliersi dal ricatto non sarà agevole. Per ora possiamo registrare solo pochi, significativi, eventi, tra i quali vanno messe di diritto tutte le resistenze (in Italia da Scansano alla Val di Susa, da Vicenza a Chiaiano e Acerra…) al consumo della vita e dell’ambiente vitale, ma possiamo esser certi che le condizioni per generalizzare la domanda continueranno a estendersi, con ciò estendendo anche la possibilità della risposta.Rifiutare il ricatto, comporta, però, l’inevitabile ricerca di un modo diverso per sopravvivere. Produrre per la vita o per il profitto sarà dilemma per milioni di individui. Dilemma non filosofico né astratto, ma prosaicamente pratico.Troverà questo dilemma la sua soluzione? E attraverso quale percorso? Solo un profeta potrebbe azzardare una risposta. Il movimento operaio che ha segnato la storia del ’900 si sgretola con lo sgretolarsi della realtà che lo aveva prodotto, e trascina con sé alla morte i suoi miti e i suoi riti, nonché tutti i programmi che aveva abbracciato e le forme organizzative che s’era dato (sindacati, partiti, cooperative, ecc). Dalle sue ceneri non potrà sorgere nulla di simile a quel che è stato, perché le condizioni stesse della sua esistenza sono state completamente stravolte.La popolazione lavoratrice deve, oggi, confrontarsi con la durezza della crisi economica e con i nuovi attacchi che gli vengono portati. Risposte di resistenza cominciano a intravedersi anche in Europa (Grecia, Irlanda, Islanda, Francia, ecc.). Ovunque c’è una commistione tra vecchi temi (e vecchie organizzazioni) e nuovi problemi. Le manifestazioni di Londra contro il G-20 hanno avuto il merito di denunciare la politica di “uscita dalla crisi” pianificata dai governi sotto il comando della finanza e delle imprese e di contrapporvi la necessità di un’“altra” politica che metta al centro i lavoratori, la vita e l’ambiente. Nei Territori francesi d’Oltremare uno sciopero determinato ha raggiunto l’obiettivo di un aumento generalizzato dei salari di 300 € mensili. In Francia gli episodi di messa sotto-accusa di manager e padroni si sono moltiplicati. In Grecia, una generazione divenuta consapevole di essere senza futuro, manifesta la sua rabbia e la sua resistenza quasi ignorando l’antico rito di dare a ciascuna lotta una sua piattaforma (e non perché stupidi, ma proprio perché, nelle condizioni attuali del capitalismo, comincia davvero a essere difficile immaginare di poter porre una specifica rivendicazione, passibile di realizzarsi durevolmente).In tutte queste manifestazioni di resistenza inizia a rendersi visibile anche una linea di soluzione di un altro fondamentale problema. Il vecchio movimento operaio trovava il suo legame fondamentale nella “comunità di lavoro” alla dipendenza dell’impresa. Per i tanti motivi che, qui, abbiamo accennato, e per altri che abbiamo, forzatamente, tenuto da parte (ruolo dell’individuo nella precedente organizzazione del lavoro e della società e attuale evoluzione di questo aspetto) quel tipo di legame va perdendo senso e pregnanza. Dalle resistenze sviluppatesi dopo Seattle e nei primi frangenti della crisi si comincia a vedere come la gelosia con la quale si afferma la propria individualità (rispetto alla massificazione della precedente organizzazione del lavoro e del suo pendant sindacale-politico) possa coniugarsi con una percezione di essere individui sociali, diversi e potenzialmente ricchi, e però bisognosi di costruire una cooperazione sociale di lotta per affrancarsi da un’esistenza che, nell’apparente “libertà individuale”, vela una feroce schiavitù al mercato e alla rendita finanziaria.Le strade che può prendere un movimento di resistenza dei lavoratori non sono pre-determinabili (e, abbiamo visto come la destra sia impegnata a costruirne anche lei, con l’esaltazione dell’odio anti-immigrati e il rilancio del nazionalismo), ma tutte dovranno fare i conti con quel dilemma.La domanda se la sinistra che ha accompagnato il ’900 possa, in tutte le sue componenti, quanto meno “intercettare” il problema è domanda che, allo stato delle cose, rischia di essere puramente retorica. Quel che urge davvero sarebbe una nuova sinistra, in grado di fare un bilancio storico dell’esperienza del movimento operaio e di ogni movimento di liberazione del secolo scorso e di aggiornarsi al corso attuale del capitalismo, non per assoggettarglisi, ma per individuare le contraddizioni esplosive nella quali si dibatte e le soluzioni antagoniste che da esse cominciano a farsi strada. Per gli uni si tratterebbe di disfarsi del feticcio dello stato e delle patologie istituzionaliste, per gli altri del feticcio dell’avanguardismo che riassume nel partito -l’organizzazione dell’avanguardia- la teoria, il programma, la strategia e la tattica, relegando le “masse” a pure esecutrici, perennemente inadeguate a esprimere una propria capacità di auto-organizzazione.Le condizioni che il corso del capitalismo sta determinando aprono, per la prima volta, la possibilità che la massa della popolazione lavoratrice (quella immensa maggioranza del mondo che non possiede altre riserve che la propria capacità di lavorare) per risolvere il problema della propria sopravvivenza (e di quella del pianeta) debba fondarsi sulla propria capacità di auto-organizzazione sociale (nel senso di essenzialmente produttiva della vita della specie umana) e politica, senza dover più dipendere dall’andamento degli “affari” di una minoranza accumulatrice.Un percorso non facile, per il quale esistono, però, le pre-condizioni tecniche, che lo stesso capitalismo ha creato con lo sviluppo delle forze produttive (per quanto molte di esse sono del tutto inutilizzabili da un punto di vista sociale e umano, come gli armamenti, l’industria dello spreco e la finanza) e possono essere create le condizioni politiche con un’alleanza tra quelle popolazioni che dallo sviluppo tecnologico hanno ricevuto, dapprima, un crescente benessere e, ora, solo immiserimento, con quelle popolazioni che sono ancora tenute forzatamente in uno stadio di sviluppo pre-capitalistico (e che non a caso si interrogano se sia meglio desiderare questo sviluppo o recuperare l’essenza comunitaria ed egualitaria delle economie con le quali ri-producevano la propria vita prima che il capitalismo arrivasse a sconvolgerle prospettandogli un benessere che non hanno mai davvero raggiunto). Un’alleanza per la quale possono svolgere un ruolo fondamentale di collegamento gli immigrati.Per garantire la sopravvivenza (e, quindi, la riproduzione) umana e dell’ambiente naturale in una società che consenta all’individuo di sfamarsi senza sudore e anche di liberare desideri e dignità, mettendosi in correlazione con gli altri esseri umani tramite rapporti non mercificati, e trasformando lo stesso lavoro da condanna ad attività creativa, liberata dalla schiavitù del denaro.Non si tratta di elaborare progetti o nuove e illusorie “grandi narrazioni”, ma di cercare di contribuire all’emergere di una prospettiva di uscita dalla crisi e dal capitalismo in crisi, senza abbandonare il terreno della resistenza immediata, ma con la consapevolezza che l’intrecciarsi dei fili di una soluzione generale non può che rafforzare anche la stessa azione immediata di resistenza.Nel frattempo, a “intercettare” le spinte di auto-organizzazione, ci prova un Tremonti (o un Obama), al puro scopo di risolverle in una rigenerazione del capitalismo, in salsa di rilancio nazional-europea (o nord-americana).Come il fascismo ha insegnato. Appunto.Marzo 2009 Questo scritto è il frutto di una discussione avviata nel Comitato lavoratori contro la guerra di Como. Il suo scopo è di cercare di contribuire a una riflessione che sia, a un tempo, bilancio dell’esperienza storica del movimento operaio e tentativo di connettere nuovi fili (o ri-conneterne di antichi) per affrontare una realtà che con la crisi del capitalismo rimette all’ordine del giorno la seria possibilità di superarlo.Senza la pretesa di sbandierare soluzioni già pronte, ma con l’impegno a proseguire la ricerca e l’azione e con la speranza di confluire in una più generale ripresa di entrambe.Il nostro recapito è: via Anzani 13, Como (tutti i lunedì alle ore 21), la nostra e-mail è: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.